 INTERVISTA a Adriana CAVARERO di Renzo COCCO (da VERONA FEDELE 1° maggio 2022) Noi abbiamo ripreso l’intervista dal sito della RETE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, che ringraziamo!
INTERVISTA a Adriana CAVARERO di Renzo COCCO (da VERONA FEDELE 1° maggio 2022) Noi abbiamo ripreso l’intervista dal sito della RETE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, che ringraziamo!
Adriana CAVARERO nasce a Bra (Cuneo) ne 1947, ma si trasferisce ancora giovane a Verona. Dopo la laurea in Filosofia all’Università di Padova, dove lavora fino al 1984, inizia l’insegnamento all’Università di Verona quale ordinaria di Filosofia politica. Conosciuta per i suoi studi di filosofia antica e di filosofia politica, è stata visiting professor presso importanti Università inglesi e americane quali Warwick, Berkeley, Meg York University e Harvard. Numerose le sue pubblicazioni tradotte in tanti Paesi del mondo. In particolare, ha dato alle stampe studi fondamentali su Platone, Hannah Arendt e sulla questione femminile partendo dai miti e dalla radice greca della violenza occidentale. Il suo ultimo libro, edito da Raffaello Cortina, si intitola “Democrazia sorgiva”. Oggi è professoressa onoraria di Filosofia politica presso l’Università di Verona.
Le immagini che arrivano dall’Ucraina invasa dall’esercito russo di Putin sono terribili e nel contempo tragiche: eccidi di massa di civili innocenti; fosse comuni piene di cadaveri giustiziati con un colpo alla testa; violenze inenarrabili a donne, bambini e anziani; distruzioni di scuole, ospedali, teatri; intere città rase al suolo. Questo intollerabile scempio che suscita orrore pone, anche dal punto di vista etico, una serie di domande che riportano alle radici dell’essere umano: perché la guerra? Quali terribili demoni guidano l’uomo-lupo? Come si può arrivare a tali livelli di mostruosità?
Di questi temi abbiamo parlato con Adriana Cavarero, una delle più note e autorevoli filosofe italiane.
Prof.ssa Cavarero, guardando alle vicende dell’umanità si constata che la guerra, da sempre e fino ai nostri giorni, ha un ruolo decisivo nel segnare le svolte della Storia e i destini dei popoli. Nell’Olimpo c’è persino un dio che la impersona. Perché la civiltà non può fare a meno della guerra?

La guerra fa purtroppo parte della storia umana, anche nel senso che è fatta dagli uomini, è un loro prodotto, un’attività specificamente umana. Gli altri animali non si fanno guerra. Ares, il dio della guerra, è ovviamente un’invenzione degli uomini che proiettano nella dimensione del divino le loro esperienze. Quanto alla sua domanda, non legherei il fatto della guerra al concetto di civiltà. Non è la civiltà, comunque la si intenda, a produrre la guerra. Se mai, è la guerra a interrompere e a contrastare il tempo di pace durante il quale la civiltà, generalmente, fiorisce e progredisce. Quindi della guerra si può fare a meno, ma bisogna seriamente impegnarsi a pensare la pace e a far sì che la guerra diventi un tabù, qualcosa di impensabile.
Veniamo all’uomo che ne è il mefistofelico artefice. Quali sono le pulsioni profonde, i demoni che lo spingono a praticare “l’arte della guerra”, ad usare la forza e la violenza, a scegliere il male anziché il bene?
Non so quali siano le pulsioni profonde che spingono alla guerra e alla violenza, e dubito comunque che siano connaturate, che facciano parte della cosiddetta “natura umana”. Se no, lei capisce, non c’è niente da fare. Constato però che, storicamente, l’esaltazione dell’arte della guerra è collegata al predominio di una cultura e di un immaginario virilista. Se vogliamo che la guerra diventi un tabù, dobbiamo innanzitutto lavorare sullo smantellamento di questa cultura e di questo immaginario, ovvero smantellare l’idea che il vero uomo, inteso come maschio – vir – sia un essere potente, prepotente e perciò, inevitabilmente, distruttore. Io non credo che il male e il bene siano concetti assoluti, per così dire immutabili e originari. E non credo neanche che stia a noi scegliere fra il bene e il male, che questa scelta avvenga nell’assoluta autonomia di uno spirito libero. Credo piuttosto che viviamo in una cultura che ha elaborato da mille ragioni per ritenere la guerra un male giustificabile, se non necessario. Come filosofa, mi occupo di contestare queste ragioni e pensare la pace come fine possibile, ovvero come ciò a cui deve mirare il lavoro culturale di chi educa le nuove generazioni.
La polis, vale a dire la comunità, celebra i generali vittoriosi e considera eroi i combattenti morti in battaglia. Per onorare i caduti a difesa della Patria, l’ateniese Pericle si rivolge 2.500 anni fa ai propri concittadini con queste parole: “Furono uomini capaci di osare, consapevoli dei loro doveri, animati nel loro agire da un vivo senso dell’onore” che meritano “l’elogio che il passare degli anni non intacca”. Dunque, la guerra (indipendentemente dall’essere offensiva o difensiva) è uno stato naturale dell’uomo e lo strumento principale dell’evoluzione della civiltà?
Lei ha fatto un ottimo esempio di quella che ho definito una cultura virilità. Ritenere che la guerra sia uno stato naturale dell’uomo e lo strumento principe dell’evoluzione della civiltà, propaga questa cultura e la rafforza. Quando leggiamo i grandi testi dei Greci, perciò, dobbiamo farlo criticamente, sennò rischiamo di fare propaganda al loro evidente marchio bellicoso e virilista. Io amo Tucidide (lo storico greco che ha riportato il discorso di Pericle agli ateniesi, ndr), la sua grandezza è immensa, ma lo leggo criticamente.
La faccia contrapposta della guerra è la pace. Ma vi sono tante paci: quella resistenza passiva e della nonviolenta; quella dell’equilibrio del terrore; la pax romana che portava a radere al suolo le città e a spargere il sale sulle macerie perché non vi crescesse più neanche un filo d’erba, ben rappresentata dalla celebre affermazione di Tacito (“fecero un deserto e lo chiamarono pace”). E c’è infine quella della ragione, dei cuori, delle menti che si basa sul principio di essere tutti uomini liberi, fratelli che condividono la Terra. Di quale pace dobbiamo dunque parlare?
Di una pace che non è un fatto, un dato, ma un fine. Una mira per un modello nonviolento di convivenza. So che non è facile, e che sembrano solo parole sentimentali e ingenue le mie. Però constato che, perlomeno per gran parte del territorio europeo, la guerra per 70 anni non aveva avuto luogo e, per la mentalità generale, era quasi diventata un tabù. Tanto è vero che, fino alla sera del 23 febbraio, nessuno di noi pensava che Putin avrebbe bombardato l’Ucraina veramente. Pensavamo che le sue fossero minacce, ma che si sarebbe fermato. In altri termini, molti di noi, compresi i cosiddetti esperti di geopolitica, ritenevano la guerra in Europa un evento impossibile. Ora che il tabù è stato violato, dobbiamo ricominciare da capo, perché la pace a cui miriamo si fa più lontana, più difficile. Parlo di Europa non solo perché sono egoisticamente europea e mi importa meno di altre parti del pianeta – me ne importa, eccome! – ma perché l’Europa, in questi settant’anni, ha potuto rappresentarsi come un laboratorio storico nel quale la guerra diventa un tabù. Pensi ad altre atrocità umane come la schiavitù. Praticata e ritenuta normale – inevitabile, utile, necessaria – per millenni, ad un certo punto, attraverso una notevole mutazione culturale, è diventata un tabù. Quindi i mutamenti culturali sono possibili.

La voce più autorevole e coraggiosa che ha condannato le guerre (compresa con forza particolare l’aggressione della Russia all’Ucraina) definendole “crudeli, insensate e sacrileghe” è stata quella di papa Francesco. Un grido, il suo, angosciato e ricorrente che sembra però rimanere inascoltato, una “voce che grida nel deserto”. Quali riflessioni le suggeriscono le parole del Santo Padre?
Il Papa è una voce importantissima per mirare alla pace. Non credo affatto che sia inascoltato; anzi, credo che la sua parola dia una spinta decisiva a coloro, credenti e non credenti, che lavorano per un mutamento culturale che ha come fine la pace. Ci incoraggia a pensare che ciò che pare impossibile sia invece possibile.
Un’altra vittima delle guerre, in particolare di questa ultima che è documentata mediatamente in ogni istante, è la verità. I massacri, le fosse comuni, le devastazioni sono imputate contemporaneamente all’aggressore e all’aggredito. I medesimi fatti, sotto gli occhi di tutti, hanno una narrazione diametralmente opposta. Il risultato è che non esiste una verità, ma tante versioni della verità. Come è possibile, in questa stordente infodemia, ristabilire il principio della “verità vera”, vale a dire dell’oggettività dei fatti e dell’assegnazione delle relative responsabilità?

Il rapporto stretto fra politica e menzogna, già noto a Platone, diventa ancor più stretto quando la politica lascia il posto alla guerra. Su questo Hannah Arendt ha scritto testi importanti: la menzogna e la propaganda sono potentissime armi di guerra e contribuiscono a rinfocolarla. Quello che mi colpisce oggi, però, non è solo l’eccesso di informazioni che impedisce di distinguere le fake news dalle verità fattuali, ma anche e soprattutto la spettacolarizzazione della guerra, trasformata in un teatro violento per il dibattito televisivo e il divertimento degli utenti. Sui social, ovviamente, la situazione è ancora peggiore. Se ne ricava un’impressione di irrealtà e naturalmente una confusione mentale che non distingue i fatti dalle finzioni.
Vorrei concludere questa intervista in una prospettiva di speranza. Le chiedo: che cosa concretamente ognuno di noi può fare per opporsi alla barbarie della guerra e per avere (uso ancora una volta le parole del Papa) “il coraggio di costruire la pace”?
Il coraggio di costruire la pace è già un gesto importante per il mutamento culturale di cui parlavo e in cui mi impegno da decenni. Intendo dire che il contrario di questo coraggio è proprio la convinzione, per così dire realistica, che la guerra appartenga alle pulsioni distruttive dell’uomo e sia perciò inevitabile. C’è sempre stata guerra e sempre ci sarà: questo è il cinismo di chi non può darsi il coraggio di costruire la pace. A rischio di sembrare folli o ingenui dobbiamo invece dire: c’è sempre stata guerra ma, se lavoriamo con coraggio a un mutamento culturale profondo, più non ci sarà. È un lavoro per me e per lei, per chiunque abbia coraggio, ma durerà, temo, il tempo di alcune generazioni.
Vi è piaciuta l’intervista e volete approfondire la conoscenza della Prof. Cavarero? Ecco gli ultimi libri che ha pubblicato.
Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse
Ti piacciono i nostri post? Vuoi sostenerci con un piccolo contributo? Ecco come fare: ci vuole un minuto!
 Tiche è la figlia di Zeus ed egli le diede il potere di decidere quale sarà la sorte di questo o quel mortale. A taluni essa concede i doni contenuti nella cornucopia, ad altri nega persino il necessario. Tiche è irresponsabile delle sue decisioni e corre qua e là facendo rimbalzare una palla per dimostrare che la sorte è cosa incerta. Ma se capita che un uomo, che essa abbia favorito, si vanti delle sue ricchezze né mai ne sacrifichi parte agli dèi, né se ne serva per alleviare le pene dei suoi concittadini, ecco che l’antica dea Nemesi si fa avanti per umiliarlo. Nemesi, che abita a Ramnunte in Attica, porta un ramo di melo in una mano e una ruota nell’altra, e in capo una corona adorna di cervi; uno scudiscio pende dalla sua cintura. Essa è figlia dell’Oceano e la sua bellezza è paragonabile a quella di Afrodite. Taluni dicono che Zeus un giorno si innamorò di Nemesi e la inseguì per terra e per mare. Benché essa mutasse continuamente forma, egli riuscì infine a violarla assumendo l’aspetto di un cigno, e dall’uovo che Nemesi depose nacque Elena, causa della guerra di Troia.
Tiche è la figlia di Zeus ed egli le diede il potere di decidere quale sarà la sorte di questo o quel mortale. A taluni essa concede i doni contenuti nella cornucopia, ad altri nega persino il necessario. Tiche è irresponsabile delle sue decisioni e corre qua e là facendo rimbalzare una palla per dimostrare che la sorte è cosa incerta. Ma se capita che un uomo, che essa abbia favorito, si vanti delle sue ricchezze né mai ne sacrifichi parte agli dèi, né se ne serva per alleviare le pene dei suoi concittadini, ecco che l’antica dea Nemesi si fa avanti per umiliarlo. Nemesi, che abita a Ramnunte in Attica, porta un ramo di melo in una mano e una ruota nell’altra, e in capo una corona adorna di cervi; uno scudiscio pende dalla sua cintura. Essa è figlia dell’Oceano e la sua bellezza è paragonabile a quella di Afrodite. Taluni dicono che Zeus un giorno si innamorò di Nemesi e la inseguì per terra e per mare. Benché essa mutasse continuamente forma, egli riuscì infine a violarla assumendo l’aspetto di un cigno, e dall’uovo che Nemesi depose nacque Elena, causa della guerra di Troia. Tiche («fortuna») come Diche ed Edo (personificazioni della Legge Naturale o Giustizia, e della Vergogna) è una divinità artificiale inventata dai primi filosofi. Nemesi («debita esecuzione») era stata la dea-Ninfa della Morte e della Vita, cui gli stessi filosofi diedero un nuovo aspetto affidandole un controllo morale su Tiche. La ruota di Tiche rappresentava in origine l’anno solare come indica il suo nome latino. Fortuna (da vortumna, «colei che fa volgere l’anno»). Quando la ruota aveva compiuto mezzo giro, il re sacro, raggiunto l’apice della sua buona sorte, doveva morire (e il suo destino era preannunciato dai cervi di Atteone presenti nella corona di Nemesi), ma quando la ruota aveva compiuto l’intero giro, il re si vendicava del rivale che l’aveva soppiantato. Lo scudiscio era usato nei tempi antichi per la flagellazione sacra, che aveva lo scopo di far fruttificare gli alberi e maturare le messi, mentre il ramo di melo era il lasciapassare del re per i Campi Elisi. La Nemesi che Zeus inseguì non era la personificazione filosofica della giustizia degli dèi, ma la dea-Ninfa originaria, il cui nome più comunemente usato fu Leda.
Tiche («fortuna») come Diche ed Edo (personificazioni della Legge Naturale o Giustizia, e della Vergogna) è una divinità artificiale inventata dai primi filosofi. Nemesi («debita esecuzione») era stata la dea-Ninfa della Morte e della Vita, cui gli stessi filosofi diedero un nuovo aspetto affidandole un controllo morale su Tiche. La ruota di Tiche rappresentava in origine l’anno solare come indica il suo nome latino. Fortuna (da vortumna, «colei che fa volgere l’anno»). Quando la ruota aveva compiuto mezzo giro, il re sacro, raggiunto l’apice della sua buona sorte, doveva morire (e il suo destino era preannunciato dai cervi di Atteone presenti nella corona di Nemesi), ma quando la ruota aveva compiuto l’intero giro, il re si vendicava del rivale che l’aveva soppiantato. Lo scudiscio era usato nei tempi antichi per la flagellazione sacra, che aveva lo scopo di far fruttificare gli alberi e maturare le messi, mentre il ramo di melo era il lasciapassare del re per i Campi Elisi. La Nemesi che Zeus inseguì non era la personificazione filosofica della giustizia degli dèi, ma la dea-Ninfa originaria, il cui nome più comunemente usato fu Leda. Nel mito pre-ellenico, è la dea che insegue il divino paredro e, benché questi si sottoponga alle trasformazioni stagionali, essa si trasforma a sua volta e infine lo divora al solstizio d’estate. Nel mito ellenico le parti sono rovesciate: la dea fugge, muta d’aspetto, ma il re la insegue e infine la viola, come nella leggenda di Zeus e di Meti o di Peleo e Teti. Probabilmente queste trasformazioni rituali erano indicate sui raggi della ruota di Nemesi; ma nelle Ciprie omeriche si parla soltanto di un pesce e di «vari animali». «Leda» è un’altra forma di Latona (in greco Letò), che fu inseguita da Pitone, e non da Zeus. I cigni erano sacri alla dea (Euripide, Ifigenia in Tauride) sia per le loro bianche piume, sia per la loro formazione di volo a V, che è un simbolo femminile, sia perché, a mezza estate, si dirigono a nord per accoppiarsi in terre ignote e si pensò che portassero con sé l’anima del re defunto. La Nemesi dei filosofi era onorata a Ramnunte dove, secondo Pausania (I 33 2-3) il comandante in capo dei Persiani, che si preparava a innalzare un trofeo marmoreo per celebrare la sua conquista dell’Attica, fu costretto a ritirarsi quando gli giunse notizia della sconfitta navale di Salamina; il marmo fu allora usato per farne una statua della dea-Ninfa locale. Nemesi. Si suppone che da quel giorno in poi tale dea-Ninfa divenne la personificazione della «Vendetta Divina» anziché della «debita esecuzione» dell’annuale dramma di morte. Dai tempi di Omero in poi, invece, nemesis aveva significato quel caldo sentimento umano che suggerisce di pagare ciò che si deve e di portare a termine il proprio compito. Ma Nemesi, la dea-Ninfa, aveva l’appellativo di Adrastea («ineluttabile»: Strabone, XIII 1 13), e Adrastea era pure il nome della nutrice di Zeus, una Ninfa del frassino; e poiché le Ninfe del frassino e le Erinni erano sorelle, nate dal sangue di Urano, ciò potrebbe spiegare come mai Nemesi finì col personificare la vendetta. Il frassino era uno degli aspetti in cui la dea si trasformava stagionalmente ed era un albero molto importante per i pastori suoi devoti, poiché era associato con i temporali e con il mese in cui nascevano gli agnelli, il terzo dell’anno sacro. Nemesi è detta figlia di Oceano, poiché come dea-Ninfa dal ramo di melo, essa rappresentava anche Afrodite nata dal mare, sorella delle Erinni.
Nel mito pre-ellenico, è la dea che insegue il divino paredro e, benché questi si sottoponga alle trasformazioni stagionali, essa si trasforma a sua volta e infine lo divora al solstizio d’estate. Nel mito ellenico le parti sono rovesciate: la dea fugge, muta d’aspetto, ma il re la insegue e infine la viola, come nella leggenda di Zeus e di Meti o di Peleo e Teti. Probabilmente queste trasformazioni rituali erano indicate sui raggi della ruota di Nemesi; ma nelle Ciprie omeriche si parla soltanto di un pesce e di «vari animali». «Leda» è un’altra forma di Latona (in greco Letò), che fu inseguita da Pitone, e non da Zeus. I cigni erano sacri alla dea (Euripide, Ifigenia in Tauride) sia per le loro bianche piume, sia per la loro formazione di volo a V, che è un simbolo femminile, sia perché, a mezza estate, si dirigono a nord per accoppiarsi in terre ignote e si pensò che portassero con sé l’anima del re defunto. La Nemesi dei filosofi era onorata a Ramnunte dove, secondo Pausania (I 33 2-3) il comandante in capo dei Persiani, che si preparava a innalzare un trofeo marmoreo per celebrare la sua conquista dell’Attica, fu costretto a ritirarsi quando gli giunse notizia della sconfitta navale di Salamina; il marmo fu allora usato per farne una statua della dea-Ninfa locale. Nemesi. Si suppone che da quel giorno in poi tale dea-Ninfa divenne la personificazione della «Vendetta Divina» anziché della «debita esecuzione» dell’annuale dramma di morte. Dai tempi di Omero in poi, invece, nemesis aveva significato quel caldo sentimento umano che suggerisce di pagare ciò che si deve e di portare a termine il proprio compito. Ma Nemesi, la dea-Ninfa, aveva l’appellativo di Adrastea («ineluttabile»: Strabone, XIII 1 13), e Adrastea era pure il nome della nutrice di Zeus, una Ninfa del frassino; e poiché le Ninfe del frassino e le Erinni erano sorelle, nate dal sangue di Urano, ciò potrebbe spiegare come mai Nemesi finì col personificare la vendetta. Il frassino era uno degli aspetti in cui la dea si trasformava stagionalmente ed era un albero molto importante per i pastori suoi devoti, poiché era associato con i temporali e con il mese in cui nascevano gli agnelli, il terzo dell’anno sacro. Nemesi è detta figlia di Oceano, poiché come dea-Ninfa dal ramo di melo, essa rappresentava anche Afrodite nata dal mare, sorella delle Erinni. Zeus generò in segreto suo figlio Zagreo in Persefone, prima che essa fosse condotta nell’Oltretomba da suo zio Ade. Egli affidò ai Cureti cretesi figli di Rea, o secondo altri ai Coribanti, il compito di custodire la culla di Zagreo nella grotta Idea e là essi gli danzavano attorno, battendo le loro armi l’una contro l’altra, come già avevano fatto attorno alla culla di Zeus sul Ditte. Ma i Titani, nemici di Zeus, sbiancandosi il volto col gesso per rendersi irriconoscibili, attesero finché i Cureti furono addormentati e a mezzanotte indussero Zagreo a seguirli, offrendogli dei giocattoli: un cono, un rombo, mele d’oro, uno specchio, un astragalo e un batuffolo di lana. Zagreo diede prova di grande coraggio quando poi i Titani gli balzarono addosso minacciosi e si sottopose a varie metamorfosi per trarli in inganno: divenne successivamente Zeus avvolto in pelle di capra, Crono che fa cadere la pioggia, un leone, un cavallo, un serpente cornuto, una tigre e un toro. A questo punto i Titani lo afferrarono saldamente per le corna, gli affondarono i denti nella carne e lo divorarono vivo.
Zeus generò in segreto suo figlio Zagreo in Persefone, prima che essa fosse condotta nell’Oltretomba da suo zio Ade. Egli affidò ai Cureti cretesi figli di Rea, o secondo altri ai Coribanti, il compito di custodire la culla di Zagreo nella grotta Idea e là essi gli danzavano attorno, battendo le loro armi l’una contro l’altra, come già avevano fatto attorno alla culla di Zeus sul Ditte. Ma i Titani, nemici di Zeus, sbiancandosi il volto col gesso per rendersi irriconoscibili, attesero finché i Cureti furono addormentati e a mezzanotte indussero Zagreo a seguirli, offrendogli dei giocattoli: un cono, un rombo, mele d’oro, uno specchio, un astragalo e un batuffolo di lana. Zagreo diede prova di grande coraggio quando poi i Titani gli balzarono addosso minacciosi e si sottopose a varie metamorfosi per trarli in inganno: divenne successivamente Zeus avvolto in pelle di capra, Crono che fa cadere la pioggia, un leone, un cavallo, un serpente cornuto, una tigre e un toro. A questo punto i Titani lo afferrarono saldamente per le corna, gli affondarono i denti nella carne e lo divorarono vivo. Questo mito si riferisce al sacrificio annuale di un fanciullo che si compiva nell’antica Creta. Un sostituto di Minosse, il re-toro, regnava per un solo giorno, partecipava a una danza simboleggiante le cinque stagioni (leone, capra, cavallo, serpente e vitello) e poi veniva ucciso e divorato crudo. I balocchi offerti dai Titani erano oggetti usati dai filosofi orfici, che continuarono la tradizione del sacrificio, ma sostituirono il fanciullo con un vitello. Il rombo era un sasso forato o un vaso, che roteando legato all’estremità di ma corda produceva un suono simile a quello del vento che s’alza; il batuffolo di lana serviva probabilmente a imbrattare con gesso i volti dei Cureti. Venivano chiamati anche Coribanti o danzatori crestati. Gli altri doni servivano a spiegare la natura della cerimonia grazie alla quale i partecipanti si identificavano con il dio: il cono era un antico emblema della dea, cui i Titani sacrificarono Zagreo; lo specchio rappresentava l’alter ego, l’ombra dell’iniziato; le mele d’oro, il suo passaporto per i Campi Elisi dopo la finta morte; l’astragalo, i suoi poteri divinatori. Un inno cretese scoperto pochi anni orsono a Paleocastro, presso la grotta di Ditte, è rivolto al Cronio, il principe dei giovani, che giunge danzando alla testa dei suoi demoni e saltella per accrescere la fertilità del suolo e la fecondità delle greggi, nonché la buona sorte delle flottiglie da pesca. Jane Harrison, in Themis, fa l’ipotesi che i protettori mediante lo scudo, menzionati nell’inno, i quali “ti prendono, o immortale fanciullo, dal fianco di Rea”, fingessero soltanto di uccidere e mangiare le vittime, secondo un rito di iniziazione alla loro società segreta. Ma tutte queste finte morti e cerimonie iniziatiche, diffuse in molte parti del mondo, pare comportassero in origine veri e propri sacrifici umani; e le metamorfosi calendariali di Zagreo lo distinguono dai soliti membri di un clan totemico.
Questo mito si riferisce al sacrificio annuale di un fanciullo che si compiva nell’antica Creta. Un sostituto di Minosse, il re-toro, regnava per un solo giorno, partecipava a una danza simboleggiante le cinque stagioni (leone, capra, cavallo, serpente e vitello) e poi veniva ucciso e divorato crudo. I balocchi offerti dai Titani erano oggetti usati dai filosofi orfici, che continuarono la tradizione del sacrificio, ma sostituirono il fanciullo con un vitello. Il rombo era un sasso forato o un vaso, che roteando legato all’estremità di ma corda produceva un suono simile a quello del vento che s’alza; il batuffolo di lana serviva probabilmente a imbrattare con gesso i volti dei Cureti. Venivano chiamati anche Coribanti o danzatori crestati. Gli altri doni servivano a spiegare la natura della cerimonia grazie alla quale i partecipanti si identificavano con il dio: il cono era un antico emblema della dea, cui i Titani sacrificarono Zagreo; lo specchio rappresentava l’alter ego, l’ombra dell’iniziato; le mele d’oro, il suo passaporto per i Campi Elisi dopo la finta morte; l’astragalo, i suoi poteri divinatori. Un inno cretese scoperto pochi anni orsono a Paleocastro, presso la grotta di Ditte, è rivolto al Cronio, il principe dei giovani, che giunge danzando alla testa dei suoi demoni e saltella per accrescere la fertilità del suolo e la fecondità delle greggi, nonché la buona sorte delle flottiglie da pesca. Jane Harrison, in Themis, fa l’ipotesi che i protettori mediante lo scudo, menzionati nell’inno, i quali “ti prendono, o immortale fanciullo, dal fianco di Rea”, fingessero soltanto di uccidere e mangiare le vittime, secondo un rito di iniziazione alla loro società segreta. Ma tutte queste finte morti e cerimonie iniziatiche, diffuse in molte parti del mondo, pare comportassero in origine veri e propri sacrifici umani; e le metamorfosi calendariali di Zagreo lo distinguono dai soliti membri di un clan totemico. La presenza non canonica della tigre come ultima metamorfosi di Zagreo è spiegabile in quanto Zagreo si identifica con Dioniso: la leggenda della morte e della resurrezione di Dioniso, infatti, è identica alla leggenda della morte e della resurrezione di Zagreo, benché la sua carne sia divorata cotta anziché cruda, e si trovi citato il nome di Rea anziché quello di Artemide. Anche Dioniso era un serpente cornuto (aveva corna e riccioli di serpente alla nascita) e i suoi seguaci orfici mangiavano la carne del dio sotto forma di tori. Zagreo divenne “Zeus avvolto in pelle di capra” poiché Zeus o il suo fanciullo di sostituzione, era asceso al cielo avvolto nella pelle della capra Amaltea. “Crono che fa scendere la pioggia” è un’allusione all’uso dei rombi nelle cerimonie propiziatorie di pioggia. In queste circostanze i Titani erano i Tifami «uomini bianchi come la calce», cioè i Cureti stessi travestiti in modo che lo spettro della vittima non potesse riconoscerli. Quando i sacrifici umani caddero in disuso. Zeus fu rappresentato nell’atto di scagliare la folgore contro i cannibali; e i Titanes, “signori della settimana di sette giorni”, furono confusi con i Titanoi, “gli uomini bianchi come la calce”, a causa della loro ostilità a Zeus.
La presenza non canonica della tigre come ultima metamorfosi di Zagreo è spiegabile in quanto Zagreo si identifica con Dioniso: la leggenda della morte e della resurrezione di Dioniso, infatti, è identica alla leggenda della morte e della resurrezione di Zagreo, benché la sua carne sia divorata cotta anziché cruda, e si trovi citato il nome di Rea anziché quello di Artemide. Anche Dioniso era un serpente cornuto (aveva corna e riccioli di serpente alla nascita) e i suoi seguaci orfici mangiavano la carne del dio sotto forma di tori. Zagreo divenne “Zeus avvolto in pelle di capra” poiché Zeus o il suo fanciullo di sostituzione, era asceso al cielo avvolto nella pelle della capra Amaltea. “Crono che fa scendere la pioggia” è un’allusione all’uso dei rombi nelle cerimonie propiziatorie di pioggia. In queste circostanze i Titani erano i Tifami «uomini bianchi come la calce», cioè i Cureti stessi travestiti in modo che lo spettro della vittima non potesse riconoscerli. Quando i sacrifici umani caddero in disuso. Zeus fu rappresentato nell’atto di scagliare la folgore contro i cannibali; e i Titanes, “signori della settimana di sette giorni”, furono confusi con i Titanoi, “gli uomini bianchi come la calce”, a causa della loro ostilità a Zeus. Ganimede, figlio del re Troo che diede il suo nome a Troia, fu il più bello dei fanciulli viventi e venne perciò scelto dagli dèi per fare da coppiere a Zeus. Si dice che Zeus, desiderando Ganimede anche come compagno di letto, si travestì con penne d’aquila e lo rapì nella pianura di Troia. Il particolare dell’aquila che rapisce Ganimede si spiega con un vaso ceretano a figure nere dove si vede un’aquila che emerge dalla coscia del re appena insediato in trono; il re è Zeus, e l’aquila personifica il potere divino che gli viene conferito (il suo ka, ossia la sua seconda personalità) così come il falco solare scendeva sui Faraoni al momento della loro incoronazione.
Ganimede, figlio del re Troo che diede il suo nome a Troia, fu il più bello dei fanciulli viventi e venne perciò scelto dagli dèi per fare da coppiere a Zeus. Si dice che Zeus, desiderando Ganimede anche come compagno di letto, si travestì con penne d’aquila e lo rapì nella pianura di Troia. Il particolare dell’aquila che rapisce Ganimede si spiega con un vaso ceretano a figure nere dove si vede un’aquila che emerge dalla coscia del re appena insediato in trono; il re è Zeus, e l’aquila personifica il potere divino che gli viene conferito (il suo ka, ossia la sua seconda personalità) così come il falco solare scendeva sui Faraoni al momento della loro incoronazione.
 Altri dicono che Ganimede fu rapito dapprima da Eos (l’Aurora), invaghitesi di lui, e che Zeus in seguito lo sottrasse alla dea. Comunque fossero andate le cose, Era considerò quel ratto come un insulto fatto a lei stessa e alla sua figliola Ebe, che fino a quel giorno era stata coppiera degli dèi; ma riuscì soltanto a irritare Zeus, che pose negli astri l’immagine di Ganimede, facendone la costellazione dell’Acquario. La costellazione dell’Acquario, identificata con Ganimede, era in origine una divinità egizia preposta alle sorgenti del Nilo e che versava acqua e non vino dal suo fiasco (Pindaro, Frammento 110); i Greci tuttavia si interessavano ben poco del Nilo. Il nettare di Zeus, che i mitografi di epoca più tarda descrissero come vino rosso sovrannaturale, era in verità un primitivo idromele, e l’ambrosia, lo squisito cibo degli dèi, pare fosse una pappa di orzo, olio e frutta schiacciata di cui si abbuffavano i re mentre i loro sudditi più poveri vivevano ancora di asfodeli, di malva e di ghiande.
Altri dicono che Ganimede fu rapito dapprima da Eos (l’Aurora), invaghitesi di lui, e che Zeus in seguito lo sottrasse alla dea. Comunque fossero andate le cose, Era considerò quel ratto come un insulto fatto a lei stessa e alla sua figliola Ebe, che fino a quel giorno era stata coppiera degli dèi; ma riuscì soltanto a irritare Zeus, che pose negli astri l’immagine di Ganimede, facendone la costellazione dell’Acquario. La costellazione dell’Acquario, identificata con Ganimede, era in origine una divinità egizia preposta alle sorgenti del Nilo e che versava acqua e non vino dal suo fiasco (Pindaro, Frammento 110); i Greci tuttavia si interessavano ben poco del Nilo. Il nettare di Zeus, che i mitografi di epoca più tarda descrissero come vino rosso sovrannaturale, era in verità un primitivo idromele, e l’ambrosia, lo squisito cibo degli dèi, pare fosse una pappa di orzo, olio e frutta schiacciata di cui si abbuffavano i re mentre i loro sudditi più poveri vivevano ancora di asfodeli, di malva e di ghiande.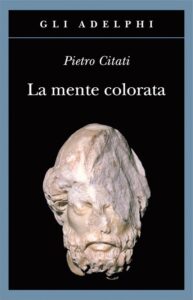 La mente colorata di Pietro Citati è un libro che offre una lettura personale e appassionata dell’Odissea di Omero, il capolavoro della letteratura greca antica. L’autore non si limita a riassumere la trama del poema, ma ne svela i significati più profondi e le sfumature più suggestive, mettendo in risalto la figura di Ulisse, l’eroe dalle mille astuzie e dalla mente poliedrica. Citati segue il viaggio di Ulisse attraverso le sue avventure e le sue prove, mostrando come egli sia capace di adattarsi a ogni situazione e di usare la sua intelligenza e la sua fantasia per superare gli ostacoli. Il libro è anche un omaggio alla bellezza della poesia omerica, che Citati rievoca con uno stile elegante e coinvolgente, ricco di immagini e metafore. La mente colorata è quindi un’opera che invita il lettore a riscoprire l’Odissea con occhi nuovi e a lasciarsi affascinare dalla sua forza narrativa e dal suo messaggio universale.
La mente colorata di Pietro Citati è un libro che offre una lettura personale e appassionata dell’Odissea di Omero, il capolavoro della letteratura greca antica. L’autore non si limita a riassumere la trama del poema, ma ne svela i significati più profondi e le sfumature più suggestive, mettendo in risalto la figura di Ulisse, l’eroe dalle mille astuzie e dalla mente poliedrica. Citati segue il viaggio di Ulisse attraverso le sue avventure e le sue prove, mostrando come egli sia capace di adattarsi a ogni situazione e di usare la sua intelligenza e la sua fantasia per superare gli ostacoli. Il libro è anche un omaggio alla bellezza della poesia omerica, che Citati rievoca con uno stile elegante e coinvolgente, ricco di immagini e metafore. La mente colorata è quindi un’opera che invita il lettore a riscoprire l’Odissea con occhi nuovi e a lasciarsi affascinare dalla sua forza narrativa e dal suo messaggio universale. Nato da un progetto a lungo accarezzato, La mente colorata è soprattutto un’interpretazione narrata dell’Odissea, dove velocità e leggerezza celano un immane lavoro di documentazione. Un racconto, dunque, che «conquista senza scampo», come ha scritto Piero Boitani, giacché «intrecciare ancora una volta il tessuto stupefacente dell’Odissea, e insieme interpretarlo nell’arazzo più vasto della letteratura greca, non è esattamente cosa facile», e Citati lo fa apparire «semplice e limpido». Ma c’è di più: per Citati, che coltiva in egual misura la passione per gli antichi e per i moderni, l’Odissea inventa le leggi dell’arte del narrare, ne sperimenta ogni forma e possibilità, sicché dal poema si dipartono luminosi tragitti, che ci proiettano verso i libri che verranno: “Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister”, “Anna Karenina”, la “Recherche” sono costruiti secondo lo stesso principio sinfonico; nell’isola dei Feaci Ulisse fonda il racconto fantastico, che ha ispirato le storie delle “Mille e una notte”, Potocki, Hoffmann, Poe, e nella capanna di Eumeo il racconto d’avventura, da cui discendono i romanzi ellenistici, Dumas, Stevenson. Comprendere l’Odissea significa, del resto, comprendere «noi stessi, l’arte moderna, il nostro futuro».
Nato da un progetto a lungo accarezzato, La mente colorata è soprattutto un’interpretazione narrata dell’Odissea, dove velocità e leggerezza celano un immane lavoro di documentazione. Un racconto, dunque, che «conquista senza scampo», come ha scritto Piero Boitani, giacché «intrecciare ancora una volta il tessuto stupefacente dell’Odissea, e insieme interpretarlo nell’arazzo più vasto della letteratura greca, non è esattamente cosa facile», e Citati lo fa apparire «semplice e limpido». Ma c’è di più: per Citati, che coltiva in egual misura la passione per gli antichi e per i moderni, l’Odissea inventa le leggi dell’arte del narrare, ne sperimenta ogni forma e possibilità, sicché dal poema si dipartono luminosi tragitti, che ci proiettano verso i libri che verranno: “Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister”, “Anna Karenina”, la “Recherche” sono costruiti secondo lo stesso principio sinfonico; nell’isola dei Feaci Ulisse fonda il racconto fantastico, che ha ispirato le storie delle “Mille e una notte”, Potocki, Hoffmann, Poe, e nella capanna di Eumeo il racconto d’avventura, da cui discendono i romanzi ellenistici, Dumas, Stevenson. Comprendere l’Odissea significa, del resto, comprendere «noi stessi, l’arte moderna, il nostro futuro». Quella di Citati è una tela ricca di trame intessute (a ricordare un po’ quella di Penelope): la narrazione del libro inizia con la presentazione delle divinità che presiedono alle avventure di Odisseo: Apollo, Ermes, le Muse. Citati passa poi in rassegna gli dèi dell’Iliade e dell’Odissea, poi presenta l’eroe dell’Iliade, Achille, e solo a pagina 88 del volume, inizia a parlare di Ulisse. Come sempre, il re di Itaca si nasconde e compare quando vuole lui, e con astuzia si inserisce nella narrazione. Dopo una breve comparsa, rieccolo scomparire per lasciar spazio, nella narrazione di Citati, al figlio Telemaco e al suo viaggio alla ricerca di notizie sul padre scomparso da 20 anni. Citati ci parla quindi di Elena e Proteo. A questo punto, finalmente, ecco arrivare il nostro navigatore: l’isola di Calipso e l’arrivo dai Feaci, dove Ulisse inizia il suo racconto (e siamo a pagina 161!). Davanti agli occhi scorrono i formaggi di Polifemo, l’isola di Circe, il viaggio nell’Ade con l’abbraccio impossibile alla madre, le sirene e il loro canto straziante. Citati passa poi al ritorno a Itaca, alla capanna di Eumeo, guardiano di porci, alla figura di Penelope, alla strage dei proci, all’ultimo misterioso viaggio di Ulisse.
Quella di Citati è una tela ricca di trame intessute (a ricordare un po’ quella di Penelope): la narrazione del libro inizia con la presentazione delle divinità che presiedono alle avventure di Odisseo: Apollo, Ermes, le Muse. Citati passa poi in rassegna gli dèi dell’Iliade e dell’Odissea, poi presenta l’eroe dell’Iliade, Achille, e solo a pagina 88 del volume, inizia a parlare di Ulisse. Come sempre, il re di Itaca si nasconde e compare quando vuole lui, e con astuzia si inserisce nella narrazione. Dopo una breve comparsa, rieccolo scomparire per lasciar spazio, nella narrazione di Citati, al figlio Telemaco e al suo viaggio alla ricerca di notizie sul padre scomparso da 20 anni. Citati ci parla quindi di Elena e Proteo. A questo punto, finalmente, ecco arrivare il nostro navigatore: l’isola di Calipso e l’arrivo dai Feaci, dove Ulisse inizia il suo racconto (e siamo a pagina 161!). Davanti agli occhi scorrono i formaggi di Polifemo, l’isola di Circe, il viaggio nell’Ade con l’abbraccio impossibile alla madre, le sirene e il loro canto straziante. Citati passa poi al ritorno a Itaca, alla capanna di Eumeo, guardiano di porci, alla figura di Penelope, alla strage dei proci, all’ultimo misterioso viaggio di Ulisse. INTERVISTA a Adriana CAVARERO di Renzo COCCO (da VERONA FEDELE 1° maggio 2022) Noi abbiamo ripreso l’intervista dal sito della
INTERVISTA a Adriana CAVARERO di Renzo COCCO (da VERONA FEDELE 1° maggio 2022) Noi abbiamo ripreso l’intervista dal sito della 


