 In occasione dei 30 anni dalla sua uscita, ripubblichiamo questa recensione a La Dea Bianca di Robert Graves, scritta da Pietro Citati e che abbiamo scovato nel ricco archivio de La Repubblica.
In occasione dei 30 anni dalla sua uscita, ripubblichiamo questa recensione a La Dea Bianca di Robert Graves, scritta da Pietro Citati e che abbiamo scovato nel ricco archivio de La Repubblica.
Breve Biografia di Pietro Citati
Una selezione di libri scritti da Pietro Citati
Il libro di Citati che La Voce delle Muse ama di più: La mente colorata, incentrato sull’Odissea
La nostra recensione a La mente colorata
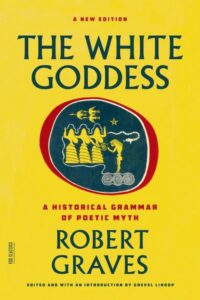
TU REGINA DELLE TENEBRE – La dea bianca di Robert Graves è il più singolare libro sulla mitologia che abbia mai letto (Adelphi, traduzione di Alberto Pelissero, lo potete acquistare qua). Robert Graves è una natura molto curiosa: sembra uno di quegli eruditi secenteschi, prodigiosi dilettanti, che dominavano venti lingue e quindici discipline: possiede una immensa biblioteca mentale, una meravigliosa memoria; ed è fantastico, estroso, dispettoso, folle come un elfo e un poeta irlandese. Ma il libro che ha scritto in molti anni di vita è più singolare di lui. Ho sempre creduto che i grandi libri sulla mitologia siano, essi stessi, dei libri mitologici: ereditano una grande tradizione mitica, la raccolgono, la interpretano; e la continuano, facendo echeggiare di nuovo tra noi quei miti, avvolgendoci nella loro melodia, contagiandoci coi loro suoni, come migliaia di anni fa o in quell’ istante miracoloso fuori dal tempo, in cui il mito per la prima volta esplose alla luce. Robert Graves ha portato questo principio sino in fondo. Con foga, con entusiasmo, con fantasia, con eccesso, talora con arbitrio mitologizza la mitologia: balza oltre la barriera che divide il vero e il falso; e il risultato è un libro straordinariamente ricco e vivo, che di colpo ci fa abitare vicino alla misteriosa Dea Bianca, a Eracle, alle sirene, alle mille divinità celtiche.
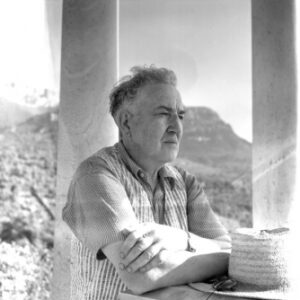 Secondo Graves, il carattere principale della mitologia è la fecondità. Un mito nasce, cresce, mette rami e foglie e frutti come gli alberi di una foresta tropicale: pullula e si moltiplica come gli arbusti di una macchia mediterranea: con una forza inarrestabile, accoglie in sé stesso altri miti, li abbraccia, li assorbe, li svuota, li trasforma in sé stesso; e continua a dilagare, fondendosi con tutte le altre invenzioni della fantasia collettiva, sino a generare un albero dalle infinite ramificazioni. La storia non incide su questa vicenda: essa, che sembra così forte, crudele e vittoriosa, non resiste al mito, che si impossessa qua di un evento là di una figura, e li identifica con i suoi rami. Non c’è nulla che Robert Graves prediliga più di queste metafore arboree. Con che amore ripete i nomi degli alberi e li descrive: la betulla, il frassino, il sorbo selvatico, l’ontano, il salice a rami rossi, il salice a foglie arrotondate, la quercia, il nocciolo, la vite, l’edera, il biancospino, il sambuco, l’abete d’ argento, il pioppo bianco, tutti sacri alla Dea Bianca. Da ogni parte fioriscono alfabeti arborei. Alle volte, potremmo leggere questo libro sulla mitologia come un libro sugli alberi, e sullo spirito degli alberi, e sull’ attenzione e sull’obbedienza che noi uomini dobbiamo portare alle loro parole.
Secondo Graves, il carattere principale della mitologia è la fecondità. Un mito nasce, cresce, mette rami e foglie e frutti come gli alberi di una foresta tropicale: pullula e si moltiplica come gli arbusti di una macchia mediterranea: con una forza inarrestabile, accoglie in sé stesso altri miti, li abbraccia, li assorbe, li svuota, li trasforma in sé stesso; e continua a dilagare, fondendosi con tutte le altre invenzioni della fantasia collettiva, sino a generare un albero dalle infinite ramificazioni. La storia non incide su questa vicenda: essa, che sembra così forte, crudele e vittoriosa, non resiste al mito, che si impossessa qua di un evento là di una figura, e li identifica con i suoi rami. Non c’è nulla che Robert Graves prediliga più di queste metafore arboree. Con che amore ripete i nomi degli alberi e li descrive: la betulla, il frassino, il sorbo selvatico, l’ontano, il salice a rami rossi, il salice a foglie arrotondate, la quercia, il nocciolo, la vite, l’edera, il biancospino, il sambuco, l’abete d’ argento, il pioppo bianco, tutti sacri alla Dea Bianca. Da ogni parte fioriscono alfabeti arborei. Alle volte, potremmo leggere questo libro sulla mitologia come un libro sugli alberi, e sullo spirito degli alberi, e sull’ attenzione e sull’obbedienza che noi uomini dobbiamo portare alle loro parole.
Un fiuto da elfo – Come conosce una sola dea, così Graves conosce un solo principio interpretativo: l’analogia, che egli applica senza freno né limite. Niente può arrestare la dilatazione dell’onda analogica, che identifica dei e dee, fino a formare una sola mitologia europea, dal Mediterraneo all’ Europa del Nord all’ Irlanda. Graves procede da un mito all’altro con salti da capriolo: possiede una velocità mentale prodigiosa; e la sua gioia più grande è quando ritrova i Milesii in Irlanda o un dio irlandese in una piega dell’Antico Testamento. Noi, che lo leggiamo, veniamo talvolta assaliti da una specie di vertigine: ci sembra che tutte le distinzioni e le differenze e le antitesi su cui è fondata la nostra cultura si dissolvano all’ improvviso nell’aria, e non resti che una nuvola rossastra che cambia e si trasforma nel cielo. Questa caccia analogica insegue una meta. Nel profondo la mitologia è, per Graves, una scrittura cifrata, come quelle che affascinavano Poe. In ogni capitolo del suo libro, incontriamo una dottrina segreta, che i sacerdoti della Dea Bianca hanno mascherato o per amore dell’enigma, o per difendere la loro sapienza dagli assalti della cultura olimpica e cristiana. In apparenza, le chiavi del segreto si sono smarrite per sempre, nascoste tra i detriti della storia. Ma Graves è un grande appassionato di enigmi, di rebus e di scritture cifrate. Con la sua passione da erudito, con il suo fiuto da elfo, non ha pace fino a quando l’enigma non balza in piena luce. Forse il tranquillo amante dei miti vorrebbe che non tutto fosse spiegato, e l’ombra materna del segreto continuasse almeno in parte a proteggere il mondo silenzioso degli dèi e delle dee.

Non ho mai compreso le violentissime passioni culturali, che costringono le persone più acute a condividere con fanatismo una tradizione, e a rifiutarne un’altra, scegliendo l’Oriente contro l’Occidente o l’Occidente contro l’Oriente. La storia della cultura e della religione umana è così ricca, variegata e complessa, e ognuno dei suoi aspetti è così fecondo, che una persona dallo sguardo puro deve accettare tutto ciò che gli uomini hanno fantasticato e immaginato. Mi sembra deplorevole che Gottfried Benn abbia esecrato il mondo femminile egeo, per celebrare i Dori e Sparta. Ma non mi sembra meno deplorevole che Robert Graves esecri gli invasori indoeuropei, che nel secondo millennio avanti Cristo portarono in Grecia la loro civiltà virile, la religione olimpica e, quasi venti secoli dopo, il cristianesimo. Graves detesta soprattutto Apollo, con la stessa furia che potrebbe provare verso un ubriacone incontrato in un pub irlandese. “È probabile che il dio greco Apollo fosse in origine il demone di una confraternita del Topo nell’ Europa totemica pregreca, il quale fece carriera con la forza delle armi, con il ricatto e con la frode, sino a diventare patrono della musica, della poesia e delle arti”. I nemici di Apollo mi sono sempre sospetti. Non capiscono quella Luce esorbitante, che contiene in sé stessa tutta la profondità della tenebra: non capiscono la poesia epica e la tragedia; né la distanza, né la Legge, né la contemplazione, né la precisione della mente, né la pienezza della gioia.
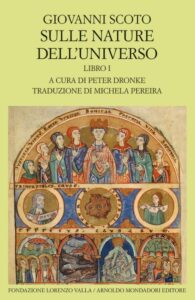 Al contrario di Benn, Graves ama la civiltà del Mediterraneo orientale, che fioriva prima che arrivassero i greci: questo grembo religioso dell’umanità, questo fecondissimo mondo femminile, che adorava la Madre. Esso possedeva una estrema facoltà di irradiazione. Se, secondo Graves, i Greci stavano a casa, sotto le loro immobili statue di marmo e di gesso, le popolazioni pregreche, sconvolte dalle invasioni indoeuropee, attraversavano i mari e le terre, sciamavano per il Mediterraneo, costeggiavano le rive della Spagna e del Portogallo e della Francia, fino a raggiungere l’Inghilterra e l’Irlanda. Il grande bosco materno, che aveva ombreggiato le secche rive del Mediterraneo, tornava a rifiorire e a gettar rami, con le stesse credenze o credenze appena variate, tra le brume e le piogge dei paesi del Nord. Quello che rende così divertente il libro di Graves è la sua ottica. Parla di miti egiziani, o egei, o greci, o ebraici: ma non ne parla vivendo in mezzo a loro, condividendo lo sguardo degli egiziani e dei greci. Lui sta fuori: abita lontano, assieme ai Pelasgi, che le antiche navi avevano portato dal Mediterraneo in Irlanda. Tutta la mitologia universale è vista con occhi irlandesi: secondo la forma e il colore che ha assunto, quando è stata trasportata tra quei boschi. L’effetto è pittoresco e appassionato. Per una volta, Graves ha tutte le ragioni storiche dalla sua parte. All’inizio del Medioevo, l’Irlanda è stata un rifugio della cultura classica: Giovanni Scoto scriveva il più bel latino che sia mai stato scritto, e traduceva gli scritti greci dello Pseudo-Dionigi; mentre l’antica mitologia pagana continuava ad esservi tramandata quando veniva repressa nel resto dell’Europa cristiana. Gli eroi di Graves non sono gli omeridi, troppo compromessi con Apollo, e nemmeno i bardi anglosassoni: ma i menestrelli popolari del Galles e dell’Irlanda. Andavano di villaggio in villaggio, o di fattoria in fattoria, intrattenendo il pubblico sotto un albero o in un angolo del focolare: accompagnavano la recitazione dei poemi con mimica e capriole, come saltimbanchi; e se si avvicinavano ai castelli, i signori li bersagliavano con gli ossi dei loro arrosti, mentre i bardi sedevano a tavola accanto al re. I menestrelli cantavano: Sono l’acqua, sono un regolo, sono un lavoratore, sono una stella, sono un serpente, sono una cella, sono una fessura, sono un ricettacolo di canti. Oppure: Io sono un vento del mare, io sono un’onda del mare, io sono un suono del mare, io sono un grifone su una scogliera, io sono una lacrima del sole, io sono un cinghiale, io sono un salmone in una pozza, io sono una lancia che dà battaglia, io sono un colle di poesia… Con la stessa passione di Yeats, Graves ama l’allegria, l’estro, il colore, il lunatico, l’orgiastico, la follia di questa tradizione popolare. Egli sa che i menestrelli, non i bardi, sono i veri cultori della sapienza: perché la loro allegria è solo un velo colorato che cela la conoscenza degli antichi misteri. I menestrelli sono, per Graves, un’incarnazione dei fairies, i folletti, che popolano il paesaggio irlandese come un campo pieno di formiche. Alti meno di un metro, con le giacche rosse o verdi, danzavano in cerchio alla luce della luna. Facevano capriole, piroette e inchini: così leggeri che nemmeno le gocce di rugiada, pur tremando sotto i loro piedi, erano disturbate dalle capriole; oppure giocavano forsennatamente a calcio, senza giacca né cappotto. Nell’ ebbrezza della danza e del gioco, ridevano a voce altissima e stridula, come uno stormo di gabbiani sulla scogliera dove passa la notte. Come i menestrelli, i fairies erano angeli decaduti. Mentre gli angeli più gravemente colpevoli vennero cacciati nell’inferno, essi peccarono più lievemente – forse per distrazione o per leggerezza, come dei ragazzi che hanno dimenticato il dogma della Trinità o hanno mancato di rispetto ai Santi. Così essi stavano a metà, né angeli né diavoli: insieme aerei e ctonii, intessuti di luce e di tenebra, come i demoni antichi. Mediavano tra l’alto e il basso: tra la terra e il cielo più alto, dove abitano gli angeli; tra i crepacci superficiali e gli abissi più profondi, dove abitano le creature del male. Da questa condizione intermedia, i fairies derivavano la loro illimitata capacità di trasformazione. Mentre il bene e il male non cambiano volto, i folletti assumevano tutte le dimensioni, tutte le forme, tutti i corpi e i colori, perché il regno intermedio è il regno del movimento. Tutto questo movimento di desiderio e di nostalgia, che nasce nel cuore dei menestrelli, degli elfi e di Graves, si dirige verso il centro del libro: la Dea Bianca lunare.
Al contrario di Benn, Graves ama la civiltà del Mediterraneo orientale, che fioriva prima che arrivassero i greci: questo grembo religioso dell’umanità, questo fecondissimo mondo femminile, che adorava la Madre. Esso possedeva una estrema facoltà di irradiazione. Se, secondo Graves, i Greci stavano a casa, sotto le loro immobili statue di marmo e di gesso, le popolazioni pregreche, sconvolte dalle invasioni indoeuropee, attraversavano i mari e le terre, sciamavano per il Mediterraneo, costeggiavano le rive della Spagna e del Portogallo e della Francia, fino a raggiungere l’Inghilterra e l’Irlanda. Il grande bosco materno, che aveva ombreggiato le secche rive del Mediterraneo, tornava a rifiorire e a gettar rami, con le stesse credenze o credenze appena variate, tra le brume e le piogge dei paesi del Nord. Quello che rende così divertente il libro di Graves è la sua ottica. Parla di miti egiziani, o egei, o greci, o ebraici: ma non ne parla vivendo in mezzo a loro, condividendo lo sguardo degli egiziani e dei greci. Lui sta fuori: abita lontano, assieme ai Pelasgi, che le antiche navi avevano portato dal Mediterraneo in Irlanda. Tutta la mitologia universale è vista con occhi irlandesi: secondo la forma e il colore che ha assunto, quando è stata trasportata tra quei boschi. L’effetto è pittoresco e appassionato. Per una volta, Graves ha tutte le ragioni storiche dalla sua parte. All’inizio del Medioevo, l’Irlanda è stata un rifugio della cultura classica: Giovanni Scoto scriveva il più bel latino che sia mai stato scritto, e traduceva gli scritti greci dello Pseudo-Dionigi; mentre l’antica mitologia pagana continuava ad esservi tramandata quando veniva repressa nel resto dell’Europa cristiana. Gli eroi di Graves non sono gli omeridi, troppo compromessi con Apollo, e nemmeno i bardi anglosassoni: ma i menestrelli popolari del Galles e dell’Irlanda. Andavano di villaggio in villaggio, o di fattoria in fattoria, intrattenendo il pubblico sotto un albero o in un angolo del focolare: accompagnavano la recitazione dei poemi con mimica e capriole, come saltimbanchi; e se si avvicinavano ai castelli, i signori li bersagliavano con gli ossi dei loro arrosti, mentre i bardi sedevano a tavola accanto al re. I menestrelli cantavano: Sono l’acqua, sono un regolo, sono un lavoratore, sono una stella, sono un serpente, sono una cella, sono una fessura, sono un ricettacolo di canti. Oppure: Io sono un vento del mare, io sono un’onda del mare, io sono un suono del mare, io sono un grifone su una scogliera, io sono una lacrima del sole, io sono un cinghiale, io sono un salmone in una pozza, io sono una lancia che dà battaglia, io sono un colle di poesia… Con la stessa passione di Yeats, Graves ama l’allegria, l’estro, il colore, il lunatico, l’orgiastico, la follia di questa tradizione popolare. Egli sa che i menestrelli, non i bardi, sono i veri cultori della sapienza: perché la loro allegria è solo un velo colorato che cela la conoscenza degli antichi misteri. I menestrelli sono, per Graves, un’incarnazione dei fairies, i folletti, che popolano il paesaggio irlandese come un campo pieno di formiche. Alti meno di un metro, con le giacche rosse o verdi, danzavano in cerchio alla luce della luna. Facevano capriole, piroette e inchini: così leggeri che nemmeno le gocce di rugiada, pur tremando sotto i loro piedi, erano disturbate dalle capriole; oppure giocavano forsennatamente a calcio, senza giacca né cappotto. Nell’ ebbrezza della danza e del gioco, ridevano a voce altissima e stridula, come uno stormo di gabbiani sulla scogliera dove passa la notte. Come i menestrelli, i fairies erano angeli decaduti. Mentre gli angeli più gravemente colpevoli vennero cacciati nell’inferno, essi peccarono più lievemente – forse per distrazione o per leggerezza, come dei ragazzi che hanno dimenticato il dogma della Trinità o hanno mancato di rispetto ai Santi. Così essi stavano a metà, né angeli né diavoli: insieme aerei e ctonii, intessuti di luce e di tenebra, come i demoni antichi. Mediavano tra l’alto e il basso: tra la terra e il cielo più alto, dove abitano gli angeli; tra i crepacci superficiali e gli abissi più profondi, dove abitano le creature del male. Da questa condizione intermedia, i fairies derivavano la loro illimitata capacità di trasformazione. Mentre il bene e il male non cambiano volto, i folletti assumevano tutte le dimensioni, tutte le forme, tutti i corpi e i colori, perché il regno intermedio è il regno del movimento. Tutto questo movimento di desiderio e di nostalgia, che nasce nel cuore dei menestrelli, degli elfi e di Graves, si dirige verso il centro del libro: la Dea Bianca lunare.
 Essa è la Signora delle creature selvagge, che frequenta le cime boscose dei colli: è la Madre della vita e della morte; è la Moira. Come Luna, è signora del cielo; come Diana, è signora della terra: come Persefone, regina dell’oltretomba; come Musa, dà l’ispirazione ai poeti. Mentre nella religione olimpica la figura femminile viene inseguita, la Dea Bianca è l’Inseguitrice e la Violentatrice. Se il maschio è lepre, lei è levriero: se lui è pesce, lei è lontra: se lui è uccello, lei è falcone; se il maschio è chicco di grano, lei è la gallina, nera, che lo inghiotte. Non ci può dunque meravigliare se la Dea Bianca ci appaia come una strega che uccide i bambini, o che riempie i nostri sogni di incubi, o come l’ape regina dal pungiglione assassino. Via via che la sua figura diventa più oscura e terrificante, una estasi voluttuosa, un desiderio di dissoluzione precipitano Graves verso l’abbraccio mortale. Con sempre nuovi colori e sfumature e parole e variazioni, Graves tenta di disegnare il ritratto della Dea Bianca. Il ritratto ci sfugge, perché nessuno più di lei si sottrae alla presa. Finché Graves afferma: la Dea Bianca è l’Iside di Apuleio – questa divinità unica, che si manifesta in ogni forma e in ogni nome. Dapprima la incontriamo nella sua forma nera: come strega e negromante, che trae giù il cielo, innalza la terra, impietra le fonti, liquefa le montagne, comanda agli Dei, spegne le stelle e il sole, illumina il Tartaro, fa rivivere i morti. Infine, la Dea si rivela. In una notte di plenilunio primaverile, il disco rotondo della luna emerge dai flutti del mare, scintillando di un abbagliante candore: il mare è quieto, il cielo senza nubi; e questa magica congiunzione tra l’umidità marina, la rugiada generatrice e i raggi lunari, è l’epifania prediletta di Iside. Mentre Lucio dorme, la dea gli appare in sogno, con i foltissimi capelli ondulati, una corona di fiori sul capo, la veste di lino cangiante, la sopravveste nerissima splendescens atro nitore e luccicante qua e là di stelle. Sappiamo che è la genitrice di tutte le cose, la signora della natura, l’inizio della storia: la madre dolcissima e misericordiosa, che aiuta e salva gli infelici; quella Madonna pagana, quella Regina coeli, quella Stella maris, che Gérard de Nerval inseguì invano per tutta la vita.
Essa è la Signora delle creature selvagge, che frequenta le cime boscose dei colli: è la Madre della vita e della morte; è la Moira. Come Luna, è signora del cielo; come Diana, è signora della terra: come Persefone, regina dell’oltretomba; come Musa, dà l’ispirazione ai poeti. Mentre nella religione olimpica la figura femminile viene inseguita, la Dea Bianca è l’Inseguitrice e la Violentatrice. Se il maschio è lepre, lei è levriero: se lui è pesce, lei è lontra: se lui è uccello, lei è falcone; se il maschio è chicco di grano, lei è la gallina, nera, che lo inghiotte. Non ci può dunque meravigliare se la Dea Bianca ci appaia come una strega che uccide i bambini, o che riempie i nostri sogni di incubi, o come l’ape regina dal pungiglione assassino. Via via che la sua figura diventa più oscura e terrificante, una estasi voluttuosa, un desiderio di dissoluzione precipitano Graves verso l’abbraccio mortale. Con sempre nuovi colori e sfumature e parole e variazioni, Graves tenta di disegnare il ritratto della Dea Bianca. Il ritratto ci sfugge, perché nessuno più di lei si sottrae alla presa. Finché Graves afferma: la Dea Bianca è l’Iside di Apuleio – questa divinità unica, che si manifesta in ogni forma e in ogni nome. Dapprima la incontriamo nella sua forma nera: come strega e negromante, che trae giù il cielo, innalza la terra, impietra le fonti, liquefa le montagne, comanda agli Dei, spegne le stelle e il sole, illumina il Tartaro, fa rivivere i morti. Infine, la Dea si rivela. In una notte di plenilunio primaverile, il disco rotondo della luna emerge dai flutti del mare, scintillando di un abbagliante candore: il mare è quieto, il cielo senza nubi; e questa magica congiunzione tra l’umidità marina, la rugiada generatrice e i raggi lunari, è l’epifania prediletta di Iside. Mentre Lucio dorme, la dea gli appare in sogno, con i foltissimi capelli ondulati, una corona di fiori sul capo, la veste di lino cangiante, la sopravveste nerissima splendescens atro nitore e luccicante qua e là di stelle. Sappiamo che è la genitrice di tutte le cose, la signora della natura, l’inizio della storia: la madre dolcissima e misericordiosa, che aiuta e salva gli infelici; quella Madonna pagana, quella Regina coeli, quella Stella maris, che Gérard de Nerval inseguì invano per tutta la vita.
 Notte di plenilunio – Non so se Iside sia veramente la Dea Bianca di Graves: dubito che la tenerezza materna, che attraeva tanto Nerval, affascinasse il suo spirito, che chiedeva agli dèi soltanto Venerazione e Terrore. È possibile che la Dea Bianca di Graves sia una dea molto più tarda: la Regina della Notte, che appare sulle scene del Flauto Magico di Mozart mentre i monti si spalancano sulla scena, o emerge all’ improvviso dall’abisso, tra il rombo furioso dei suoni. Certo, essa è ancora Iside: ha la stessa “nerissima sopravveste brillante di atro splendore” e luccicante di stelle; e conosce i dolori di Iside-Demetra, che percorre la terra coperta da un velo oscuro cercando le tracce della figlia scomparsa. Ma quando canta tra la tempesta dei suoni: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen,Tod und Verzweiflung flammet um mich her!…… Hort, Rachegotter! Hort der Mutter Schwur! La vendetta dell’inferno arde nel mio cuore,morte e disperazione fiammeggiano intorno a me!…… Udite, dei della Vendetta! Udite il giuramento della madre!: allora essa diventa un’oscura Erinni, che lacera ogni legame della natura. Forse la Dea Bianca, che Graves ha inseguito attraverso tante incarnazioni e trasformazioni, è, nel profondo, una Regina della Tenebra.
Notte di plenilunio – Non so se Iside sia veramente la Dea Bianca di Graves: dubito che la tenerezza materna, che attraeva tanto Nerval, affascinasse il suo spirito, che chiedeva agli dèi soltanto Venerazione e Terrore. È possibile che la Dea Bianca di Graves sia una dea molto più tarda: la Regina della Notte, che appare sulle scene del Flauto Magico di Mozart mentre i monti si spalancano sulla scena, o emerge all’ improvviso dall’abisso, tra il rombo furioso dei suoni. Certo, essa è ancora Iside: ha la stessa “nerissima sopravveste brillante di atro splendore” e luccicante di stelle; e conosce i dolori di Iside-Demetra, che percorre la terra coperta da un velo oscuro cercando le tracce della figlia scomparsa. Ma quando canta tra la tempesta dei suoni: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen,Tod und Verzweiflung flammet um mich her!…… Hort, Rachegotter! Hort der Mutter Schwur! La vendetta dell’inferno arde nel mio cuore,morte e disperazione fiammeggiano intorno a me!…… Udite, dei della Vendetta! Udite il giuramento della madre!: allora essa diventa un’oscura Erinni, che lacera ogni legame della natura. Forse la Dea Bianca, che Graves ha inseguito attraverso tante incarnazioni e trasformazioni, è, nel profondo, una Regina della Tenebra.
PIETRO CITATI (pubblicato il 12 febbraio 1993 su La Repubblica: vai all’originale nell’archivio del quotidiano romano)
Graves, Robert. 1948. La Dea Bianca. Milano, Adelphi, 1992. 596 pagine, 20 Euro.
La recensione a La Dea Bianca de La Voce delle Muse
Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse
Chi è Robert Graves e recensioni ad altri suoi volumi
Poetica di Robert Graves
I libri di Robert Graves
 Zeus generò in segreto suo figlio Zagreo in Persefone, prima che essa fosse condotta nell’Oltretomba da suo zio Ade. Egli affidò ai Cureti cretesi figli di Rea, o secondo altri ai Coribanti, il compito di custodire la culla di Zagreo nella grotta Idea e là essi gli danzavano attorno, battendo le loro armi l’una contro l’altra, come già avevano fatto attorno alla culla di Zeus sul Ditte. Ma i Titani, nemici di Zeus, sbiancandosi il volto col gesso per rendersi irriconoscibili, attesero finché i Cureti furono addormentati e a mezzanotte indussero Zagreo a seguirli, offrendogli dei giocattoli: un cono, un rombo, mele d’oro, uno specchio, un astragalo e un batuffolo di lana. Zagreo diede prova di grande coraggio quando poi i Titani gli balzarono addosso minacciosi e si sottopose a varie metamorfosi per trarli in inganno: divenne successivamente Zeus avvolto in pelle di capra, Crono che fa cadere la pioggia, un leone, un cavallo, un serpente cornuto, una tigre e un toro. A questo punto i Titani lo afferrarono saldamente per le corna, gli affondarono i denti nella carne e lo divorarono vivo.
Zeus generò in segreto suo figlio Zagreo in Persefone, prima che essa fosse condotta nell’Oltretomba da suo zio Ade. Egli affidò ai Cureti cretesi figli di Rea, o secondo altri ai Coribanti, il compito di custodire la culla di Zagreo nella grotta Idea e là essi gli danzavano attorno, battendo le loro armi l’una contro l’altra, come già avevano fatto attorno alla culla di Zeus sul Ditte. Ma i Titani, nemici di Zeus, sbiancandosi il volto col gesso per rendersi irriconoscibili, attesero finché i Cureti furono addormentati e a mezzanotte indussero Zagreo a seguirli, offrendogli dei giocattoli: un cono, un rombo, mele d’oro, uno specchio, un astragalo e un batuffolo di lana. Zagreo diede prova di grande coraggio quando poi i Titani gli balzarono addosso minacciosi e si sottopose a varie metamorfosi per trarli in inganno: divenne successivamente Zeus avvolto in pelle di capra, Crono che fa cadere la pioggia, un leone, un cavallo, un serpente cornuto, una tigre e un toro. A questo punto i Titani lo afferrarono saldamente per le corna, gli affondarono i denti nella carne e lo divorarono vivo. Questo mito si riferisce al sacrificio annuale di un fanciullo che si compiva nell’antica Creta. Un sostituto di Minosse, il re-toro, regnava per un solo giorno, partecipava a una danza simboleggiante le cinque stagioni (leone, capra, cavallo, serpente e vitello) e poi veniva ucciso e divorato crudo. I balocchi offerti dai Titani erano oggetti usati dai filosofi orfici, che continuarono la tradizione del sacrificio, ma sostituirono il fanciullo con un vitello. Il rombo era un sasso forato o un vaso, che roteando legato all’estremità di ma corda produceva un suono simile a quello del vento che s’alza; il batuffolo di lana serviva probabilmente a imbrattare con gesso i volti dei Cureti. Venivano chiamati anche Coribanti o danzatori crestati. Gli altri doni servivano a spiegare la natura della cerimonia grazie alla quale i partecipanti si identificavano con il dio: il cono era un antico emblema della dea, cui i Titani sacrificarono Zagreo; lo specchio rappresentava l’alter ego, l’ombra dell’iniziato; le mele d’oro, il suo passaporto per i Campi Elisi dopo la finta morte; l’astragalo, i suoi poteri divinatori. Un inno cretese scoperto pochi anni orsono a Paleocastro, presso la grotta di Ditte, è rivolto al Cronio, il principe dei giovani, che giunge danzando alla testa dei suoi demoni e saltella per accrescere la fertilità del suolo e la fecondità delle greggi, nonché la buona sorte delle flottiglie da pesca. Jane Harrison, in Themis, fa l’ipotesi che i protettori mediante lo scudo, menzionati nell’inno, i quali “ti prendono, o immortale fanciullo, dal fianco di Rea”, fingessero soltanto di uccidere e mangiare le vittime, secondo un rito di iniziazione alla loro società segreta. Ma tutte queste finte morti e cerimonie iniziatiche, diffuse in molte parti del mondo, pare comportassero in origine veri e propri sacrifici umani; e le metamorfosi calendariali di Zagreo lo distinguono dai soliti membri di un clan totemico.
Questo mito si riferisce al sacrificio annuale di un fanciullo che si compiva nell’antica Creta. Un sostituto di Minosse, il re-toro, regnava per un solo giorno, partecipava a una danza simboleggiante le cinque stagioni (leone, capra, cavallo, serpente e vitello) e poi veniva ucciso e divorato crudo. I balocchi offerti dai Titani erano oggetti usati dai filosofi orfici, che continuarono la tradizione del sacrificio, ma sostituirono il fanciullo con un vitello. Il rombo era un sasso forato o un vaso, che roteando legato all’estremità di ma corda produceva un suono simile a quello del vento che s’alza; il batuffolo di lana serviva probabilmente a imbrattare con gesso i volti dei Cureti. Venivano chiamati anche Coribanti o danzatori crestati. Gli altri doni servivano a spiegare la natura della cerimonia grazie alla quale i partecipanti si identificavano con il dio: il cono era un antico emblema della dea, cui i Titani sacrificarono Zagreo; lo specchio rappresentava l’alter ego, l’ombra dell’iniziato; le mele d’oro, il suo passaporto per i Campi Elisi dopo la finta morte; l’astragalo, i suoi poteri divinatori. Un inno cretese scoperto pochi anni orsono a Paleocastro, presso la grotta di Ditte, è rivolto al Cronio, il principe dei giovani, che giunge danzando alla testa dei suoi demoni e saltella per accrescere la fertilità del suolo e la fecondità delle greggi, nonché la buona sorte delle flottiglie da pesca. Jane Harrison, in Themis, fa l’ipotesi che i protettori mediante lo scudo, menzionati nell’inno, i quali “ti prendono, o immortale fanciullo, dal fianco di Rea”, fingessero soltanto di uccidere e mangiare le vittime, secondo un rito di iniziazione alla loro società segreta. Ma tutte queste finte morti e cerimonie iniziatiche, diffuse in molte parti del mondo, pare comportassero in origine veri e propri sacrifici umani; e le metamorfosi calendariali di Zagreo lo distinguono dai soliti membri di un clan totemico. La presenza non canonica della tigre come ultima metamorfosi di Zagreo è spiegabile in quanto Zagreo si identifica con Dioniso: la leggenda della morte e della resurrezione di Dioniso, infatti, è identica alla leggenda della morte e della resurrezione di Zagreo, benché la sua carne sia divorata cotta anziché cruda, e si trovi citato il nome di Rea anziché quello di Artemide. Anche Dioniso era un serpente cornuto (aveva corna e riccioli di serpente alla nascita) e i suoi seguaci orfici mangiavano la carne del dio sotto forma di tori. Zagreo divenne “Zeus avvolto in pelle di capra” poiché Zeus o il suo fanciullo di sostituzione, era asceso al cielo avvolto nella pelle della capra Amaltea. “Crono che fa scendere la pioggia” è un’allusione all’uso dei rombi nelle cerimonie propiziatorie di pioggia. In queste circostanze i Titani erano i Tifami «uomini bianchi come la calce», cioè i Cureti stessi travestiti in modo che lo spettro della vittima non potesse riconoscerli. Quando i sacrifici umani caddero in disuso. Zeus fu rappresentato nell’atto di scagliare la folgore contro i cannibali; e i Titanes, “signori della settimana di sette giorni”, furono confusi con i Titanoi, “gli uomini bianchi come la calce”, a causa della loro ostilità a Zeus.
La presenza non canonica della tigre come ultima metamorfosi di Zagreo è spiegabile in quanto Zagreo si identifica con Dioniso: la leggenda della morte e della resurrezione di Dioniso, infatti, è identica alla leggenda della morte e della resurrezione di Zagreo, benché la sua carne sia divorata cotta anziché cruda, e si trovi citato il nome di Rea anziché quello di Artemide. Anche Dioniso era un serpente cornuto (aveva corna e riccioli di serpente alla nascita) e i suoi seguaci orfici mangiavano la carne del dio sotto forma di tori. Zagreo divenne “Zeus avvolto in pelle di capra” poiché Zeus o il suo fanciullo di sostituzione, era asceso al cielo avvolto nella pelle della capra Amaltea. “Crono che fa scendere la pioggia” è un’allusione all’uso dei rombi nelle cerimonie propiziatorie di pioggia. In queste circostanze i Titani erano i Tifami «uomini bianchi come la calce», cioè i Cureti stessi travestiti in modo che lo spettro della vittima non potesse riconoscerli. Quando i sacrifici umani caddero in disuso. Zeus fu rappresentato nell’atto di scagliare la folgore contro i cannibali; e i Titanes, “signori della settimana di sette giorni”, furono confusi con i Titanoi, “gli uomini bianchi come la calce”, a causa della loro ostilità a Zeus. Ganimede, figlio del re Troo che diede il suo nome a Troia, fu il più bello dei fanciulli viventi e venne perciò scelto dagli dèi per fare da coppiere a Zeus. Si dice che Zeus, desiderando Ganimede anche come compagno di letto, si travestì con penne d’aquila e lo rapì nella pianura di Troia. Il particolare dell’aquila che rapisce Ganimede si spiega con un vaso ceretano a figure nere dove si vede un’aquila che emerge dalla coscia del re appena insediato in trono; il re è Zeus, e l’aquila personifica il potere divino che gli viene conferito (il suo ka, ossia la sua seconda personalità) così come il falco solare scendeva sui Faraoni al momento della loro incoronazione.
Ganimede, figlio del re Troo che diede il suo nome a Troia, fu il più bello dei fanciulli viventi e venne perciò scelto dagli dèi per fare da coppiere a Zeus. Si dice che Zeus, desiderando Ganimede anche come compagno di letto, si travestì con penne d’aquila e lo rapì nella pianura di Troia. Il particolare dell’aquila che rapisce Ganimede si spiega con un vaso ceretano a figure nere dove si vede un’aquila che emerge dalla coscia del re appena insediato in trono; il re è Zeus, e l’aquila personifica il potere divino che gli viene conferito (il suo ka, ossia la sua seconda personalità) così come il falco solare scendeva sui Faraoni al momento della loro incoronazione.
 Altri dicono che Ganimede fu rapito dapprima da Eos (l’Aurora), invaghitesi di lui, e che Zeus in seguito lo sottrasse alla dea. Comunque fossero andate le cose, Era considerò quel ratto come un insulto fatto a lei stessa e alla sua figliola Ebe, che fino a quel giorno era stata coppiera degli dèi; ma riuscì soltanto a irritare Zeus, che pose negli astri l’immagine di Ganimede, facendone la costellazione dell’Acquario. La costellazione dell’Acquario, identificata con Ganimede, era in origine una divinità egizia preposta alle sorgenti del Nilo e che versava acqua e non vino dal suo fiasco (Pindaro, Frammento 110); i Greci tuttavia si interessavano ben poco del Nilo. Il nettare di Zeus, che i mitografi di epoca più tarda descrissero come vino rosso sovrannaturale, era in verità un primitivo idromele, e l’ambrosia, lo squisito cibo degli dèi, pare fosse una pappa di orzo, olio e frutta schiacciata di cui si abbuffavano i re mentre i loro sudditi più poveri vivevano ancora di asfodeli, di malva e di ghiande.
Altri dicono che Ganimede fu rapito dapprima da Eos (l’Aurora), invaghitesi di lui, e che Zeus in seguito lo sottrasse alla dea. Comunque fossero andate le cose, Era considerò quel ratto come un insulto fatto a lei stessa e alla sua figliola Ebe, che fino a quel giorno era stata coppiera degli dèi; ma riuscì soltanto a irritare Zeus, che pose negli astri l’immagine di Ganimede, facendone la costellazione dell’Acquario. La costellazione dell’Acquario, identificata con Ganimede, era in origine una divinità egizia preposta alle sorgenti del Nilo e che versava acqua e non vino dal suo fiasco (Pindaro, Frammento 110); i Greci tuttavia si interessavano ben poco del Nilo. Il nettare di Zeus, che i mitografi di epoca più tarda descrissero come vino rosso sovrannaturale, era in verità un primitivo idromele, e l’ambrosia, lo squisito cibo degli dèi, pare fosse una pappa di orzo, olio e frutta schiacciata di cui si abbuffavano i re mentre i loro sudditi più poveri vivevano ancora di asfodeli, di malva e di ghiande. In occasione dei 30 anni dalla sua uscita, ripubblichiamo questa recensione a La Dea Bianca di Robert Graves, scritta da Pietro Citati e che abbiamo scovato nel ricco
In occasione dei 30 anni dalla sua uscita, ripubblichiamo questa recensione a La Dea Bianca di Robert Graves, scritta da Pietro Citati e che abbiamo scovato nel ricco 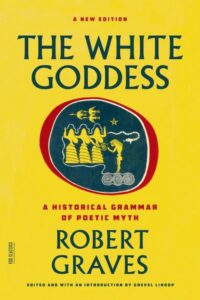
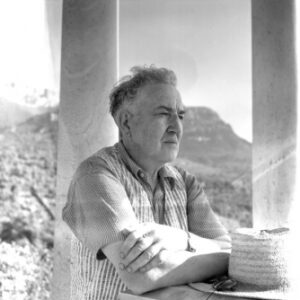 Secondo Graves, il carattere principale della mitologia è la fecondità. Un mito nasce, cresce, mette rami e foglie e frutti come gli alberi di una foresta tropicale: pullula e si moltiplica come gli arbusti di una macchia mediterranea: con una forza inarrestabile, accoglie in sé stesso altri miti, li abbraccia, li assorbe, li svuota, li trasforma in sé stesso; e continua a dilagare, fondendosi con tutte le altre invenzioni della fantasia collettiva, sino a generare un albero dalle infinite ramificazioni. La storia non incide su questa vicenda: essa, che sembra così forte, crudele e vittoriosa, non resiste al mito, che si impossessa qua di un evento là di una figura, e li identifica con i suoi rami. Non c’è nulla che Robert Graves prediliga più di queste metafore arboree. Con che amore ripete i nomi degli alberi e li descrive: la betulla, il frassino, il sorbo selvatico, l’ontano, il salice a rami rossi, il salice a foglie arrotondate, la quercia, il nocciolo, la vite, l’edera, il biancospino, il sambuco, l’abete d’ argento, il pioppo bianco, tutti sacri alla Dea Bianca. Da ogni parte fioriscono alfabeti arborei. Alle volte, potremmo leggere questo libro sulla mitologia come un libro sugli alberi, e sullo spirito degli alberi, e sull’ attenzione e sull’obbedienza che noi uomini dobbiamo portare alle loro parole.
Secondo Graves, il carattere principale della mitologia è la fecondità. Un mito nasce, cresce, mette rami e foglie e frutti come gli alberi di una foresta tropicale: pullula e si moltiplica come gli arbusti di una macchia mediterranea: con una forza inarrestabile, accoglie in sé stesso altri miti, li abbraccia, li assorbe, li svuota, li trasforma in sé stesso; e continua a dilagare, fondendosi con tutte le altre invenzioni della fantasia collettiva, sino a generare un albero dalle infinite ramificazioni. La storia non incide su questa vicenda: essa, che sembra così forte, crudele e vittoriosa, non resiste al mito, che si impossessa qua di un evento là di una figura, e li identifica con i suoi rami. Non c’è nulla che Robert Graves prediliga più di queste metafore arboree. Con che amore ripete i nomi degli alberi e li descrive: la betulla, il frassino, il sorbo selvatico, l’ontano, il salice a rami rossi, il salice a foglie arrotondate, la quercia, il nocciolo, la vite, l’edera, il biancospino, il sambuco, l’abete d’ argento, il pioppo bianco, tutti sacri alla Dea Bianca. Da ogni parte fioriscono alfabeti arborei. Alle volte, potremmo leggere questo libro sulla mitologia come un libro sugli alberi, e sullo spirito degli alberi, e sull’ attenzione e sull’obbedienza che noi uomini dobbiamo portare alle loro parole.
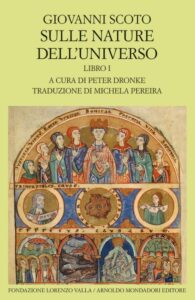 Al contrario di Benn, Graves ama la civiltà del Mediterraneo orientale, che fioriva prima che arrivassero i greci: questo grembo religioso dell’umanità, questo fecondissimo mondo femminile, che adorava la Madre. Esso possedeva una estrema facoltà di irradiazione. Se, secondo Graves, i Greci stavano a casa, sotto le loro immobili statue di marmo e di gesso, le popolazioni pregreche, sconvolte dalle invasioni indoeuropee, attraversavano i mari e le terre, sciamavano per il Mediterraneo, costeggiavano le rive della Spagna e del Portogallo e della Francia, fino a raggiungere l’Inghilterra e l’Irlanda. Il grande bosco materno, che aveva ombreggiato le secche rive del Mediterraneo, tornava a rifiorire e a gettar rami, con le stesse credenze o credenze appena variate, tra le brume e le piogge dei paesi del Nord. Quello che rende così divertente il libro di Graves è la sua ottica. Parla di miti egiziani, o egei, o greci, o ebraici: ma non ne parla vivendo in mezzo a loro, condividendo lo sguardo degli egiziani e dei greci. Lui sta fuori: abita lontano, assieme ai Pelasgi, che le antiche navi avevano portato dal Mediterraneo in Irlanda. Tutta la mitologia universale è vista con occhi irlandesi: secondo la forma e il colore che ha assunto, quando è stata trasportata tra quei boschi. L’effetto è pittoresco e appassionato. Per una volta, Graves ha tutte le ragioni storiche dalla sua parte. All’inizio del Medioevo, l’Irlanda è stata un rifugio della cultura classica: Giovanni Scoto scriveva il più bel latino che sia mai stato scritto, e traduceva gli scritti greci dello Pseudo-Dionigi; mentre l’antica mitologia pagana continuava ad esservi tramandata quando veniva repressa nel resto dell’Europa cristiana. Gli eroi di Graves non sono gli omeridi, troppo compromessi con Apollo, e nemmeno i bardi anglosassoni: ma i menestrelli popolari del Galles e dell’Irlanda. Andavano di villaggio in villaggio, o di fattoria in fattoria, intrattenendo il pubblico sotto un albero o in un angolo del focolare: accompagnavano la recitazione dei poemi con mimica e capriole, come saltimbanchi; e se si avvicinavano ai castelli, i signori li bersagliavano con gli ossi dei loro arrosti, mentre i bardi sedevano a tavola accanto al re. I menestrelli cantavano: Sono l’acqua, sono un regolo, sono un lavoratore, sono una stella, sono un serpente, sono una cella, sono una fessura, sono un ricettacolo di canti. Oppure: Io sono un vento del mare, io sono un’onda del mare, io sono un suono del mare, io sono un grifone su una scogliera, io sono una lacrima del sole, io sono un cinghiale, io sono un salmone in una pozza, io sono una lancia che dà battaglia, io sono un colle di poesia… Con la stessa passione di Yeats, Graves ama l’allegria, l’estro, il colore, il lunatico, l’orgiastico, la follia di questa tradizione popolare. Egli sa che i menestrelli, non i bardi, sono i veri cultori della sapienza: perché la loro allegria è solo un velo colorato che cela la conoscenza degli antichi misteri. I menestrelli sono, per Graves, un’incarnazione dei fairies, i folletti, che popolano il paesaggio irlandese come un campo pieno di formiche. Alti meno di un metro, con le giacche rosse o verdi, danzavano in cerchio alla luce della luna. Facevano capriole, piroette e inchini: così leggeri che nemmeno le gocce di rugiada, pur tremando sotto i loro piedi, erano disturbate dalle capriole; oppure giocavano forsennatamente a calcio, senza giacca né cappotto. Nell’ ebbrezza della danza e del gioco, ridevano a voce altissima e stridula, come uno stormo di gabbiani sulla scogliera dove passa la notte. Come i menestrelli, i fairies erano angeli decaduti. Mentre gli angeli più gravemente colpevoli vennero cacciati nell’inferno, essi peccarono più lievemente – forse per distrazione o per leggerezza, come dei ragazzi che hanno dimenticato il dogma della Trinità o hanno mancato di rispetto ai Santi. Così essi stavano a metà, né angeli né diavoli: insieme aerei e ctonii, intessuti di luce e di tenebra, come i demoni antichi. Mediavano tra l’alto e il basso: tra la terra e il cielo più alto, dove abitano gli angeli; tra i crepacci superficiali e gli abissi più profondi, dove abitano le creature del male. Da questa condizione intermedia, i fairies derivavano la loro illimitata capacità di trasformazione. Mentre il bene e il male non cambiano volto, i folletti assumevano tutte le dimensioni, tutte le forme, tutti i corpi e i colori, perché il regno intermedio è il regno del movimento. Tutto questo movimento di desiderio e di nostalgia, che nasce nel cuore dei menestrelli, degli elfi e di Graves, si dirige verso il centro del libro: la Dea Bianca lunare.
Al contrario di Benn, Graves ama la civiltà del Mediterraneo orientale, che fioriva prima che arrivassero i greci: questo grembo religioso dell’umanità, questo fecondissimo mondo femminile, che adorava la Madre. Esso possedeva una estrema facoltà di irradiazione. Se, secondo Graves, i Greci stavano a casa, sotto le loro immobili statue di marmo e di gesso, le popolazioni pregreche, sconvolte dalle invasioni indoeuropee, attraversavano i mari e le terre, sciamavano per il Mediterraneo, costeggiavano le rive della Spagna e del Portogallo e della Francia, fino a raggiungere l’Inghilterra e l’Irlanda. Il grande bosco materno, che aveva ombreggiato le secche rive del Mediterraneo, tornava a rifiorire e a gettar rami, con le stesse credenze o credenze appena variate, tra le brume e le piogge dei paesi del Nord. Quello che rende così divertente il libro di Graves è la sua ottica. Parla di miti egiziani, o egei, o greci, o ebraici: ma non ne parla vivendo in mezzo a loro, condividendo lo sguardo degli egiziani e dei greci. Lui sta fuori: abita lontano, assieme ai Pelasgi, che le antiche navi avevano portato dal Mediterraneo in Irlanda. Tutta la mitologia universale è vista con occhi irlandesi: secondo la forma e il colore che ha assunto, quando è stata trasportata tra quei boschi. L’effetto è pittoresco e appassionato. Per una volta, Graves ha tutte le ragioni storiche dalla sua parte. All’inizio del Medioevo, l’Irlanda è stata un rifugio della cultura classica: Giovanni Scoto scriveva il più bel latino che sia mai stato scritto, e traduceva gli scritti greci dello Pseudo-Dionigi; mentre l’antica mitologia pagana continuava ad esservi tramandata quando veniva repressa nel resto dell’Europa cristiana. Gli eroi di Graves non sono gli omeridi, troppo compromessi con Apollo, e nemmeno i bardi anglosassoni: ma i menestrelli popolari del Galles e dell’Irlanda. Andavano di villaggio in villaggio, o di fattoria in fattoria, intrattenendo il pubblico sotto un albero o in un angolo del focolare: accompagnavano la recitazione dei poemi con mimica e capriole, come saltimbanchi; e se si avvicinavano ai castelli, i signori li bersagliavano con gli ossi dei loro arrosti, mentre i bardi sedevano a tavola accanto al re. I menestrelli cantavano: Sono l’acqua, sono un regolo, sono un lavoratore, sono una stella, sono un serpente, sono una cella, sono una fessura, sono un ricettacolo di canti. Oppure: Io sono un vento del mare, io sono un’onda del mare, io sono un suono del mare, io sono un grifone su una scogliera, io sono una lacrima del sole, io sono un cinghiale, io sono un salmone in una pozza, io sono una lancia che dà battaglia, io sono un colle di poesia… Con la stessa passione di Yeats, Graves ama l’allegria, l’estro, il colore, il lunatico, l’orgiastico, la follia di questa tradizione popolare. Egli sa che i menestrelli, non i bardi, sono i veri cultori della sapienza: perché la loro allegria è solo un velo colorato che cela la conoscenza degli antichi misteri. I menestrelli sono, per Graves, un’incarnazione dei fairies, i folletti, che popolano il paesaggio irlandese come un campo pieno di formiche. Alti meno di un metro, con le giacche rosse o verdi, danzavano in cerchio alla luce della luna. Facevano capriole, piroette e inchini: così leggeri che nemmeno le gocce di rugiada, pur tremando sotto i loro piedi, erano disturbate dalle capriole; oppure giocavano forsennatamente a calcio, senza giacca né cappotto. Nell’ ebbrezza della danza e del gioco, ridevano a voce altissima e stridula, come uno stormo di gabbiani sulla scogliera dove passa la notte. Come i menestrelli, i fairies erano angeli decaduti. Mentre gli angeli più gravemente colpevoli vennero cacciati nell’inferno, essi peccarono più lievemente – forse per distrazione o per leggerezza, come dei ragazzi che hanno dimenticato il dogma della Trinità o hanno mancato di rispetto ai Santi. Così essi stavano a metà, né angeli né diavoli: insieme aerei e ctonii, intessuti di luce e di tenebra, come i demoni antichi. Mediavano tra l’alto e il basso: tra la terra e il cielo più alto, dove abitano gli angeli; tra i crepacci superficiali e gli abissi più profondi, dove abitano le creature del male. Da questa condizione intermedia, i fairies derivavano la loro illimitata capacità di trasformazione. Mentre il bene e il male non cambiano volto, i folletti assumevano tutte le dimensioni, tutte le forme, tutti i corpi e i colori, perché il regno intermedio è il regno del movimento. Tutto questo movimento di desiderio e di nostalgia, che nasce nel cuore dei menestrelli, degli elfi e di Graves, si dirige verso il centro del libro: la Dea Bianca lunare. Essa è la Signora delle creature selvagge, che frequenta le cime boscose dei colli: è la Madre della vita e della morte; è la Moira. Come Luna, è signora del cielo; come Diana, è signora della terra: come Persefone, regina dell’oltretomba; come Musa, dà l’ispirazione ai poeti. Mentre nella religione olimpica la figura femminile viene inseguita, la Dea Bianca è l’Inseguitrice e la Violentatrice. Se il maschio è lepre, lei è levriero: se lui è pesce, lei è lontra: se lui è uccello, lei è falcone; se il maschio è chicco di grano, lei è la gallina, nera, che lo inghiotte. Non ci può dunque meravigliare se la Dea Bianca ci appaia come una strega che uccide i bambini, o che riempie i nostri sogni di incubi, o come l’ape regina dal pungiglione assassino. Via via che la sua figura diventa più oscura e terrificante, una estasi voluttuosa, un desiderio di dissoluzione precipitano Graves verso l’abbraccio mortale. Con sempre nuovi colori e sfumature e parole e variazioni, Graves tenta di disegnare il ritratto della Dea Bianca. Il ritratto ci sfugge, perché nessuno più di lei si sottrae alla presa. Finché Graves afferma: la Dea Bianca è l’Iside di Apuleio – questa divinità unica, che si manifesta in ogni forma e in ogni nome. Dapprima la incontriamo nella sua forma nera: come strega e negromante, che trae giù il cielo, innalza la terra, impietra le fonti, liquefa le montagne, comanda agli Dei, spegne le stelle e il sole, illumina il Tartaro, fa rivivere i morti. Infine, la Dea si rivela. In una notte di plenilunio primaverile, il disco rotondo della luna emerge dai flutti del mare, scintillando di un abbagliante candore: il mare è quieto, il cielo senza nubi; e questa magica congiunzione tra l’umidità marina, la rugiada generatrice e i raggi lunari, è l’epifania prediletta di Iside. Mentre Lucio dorme, la dea gli appare in sogno, con i foltissimi capelli ondulati, una corona di fiori sul capo, la veste di lino cangiante, la sopravveste nerissima splendescens atro nitore e luccicante qua e là di stelle. Sappiamo che è la genitrice di tutte le cose, la signora della natura, l’inizio della storia: la madre dolcissima e misericordiosa, che aiuta e salva gli infelici; quella Madonna pagana, quella Regina coeli, quella Stella maris, che Gérard de Nerval inseguì invano per tutta la vita.
Essa è la Signora delle creature selvagge, che frequenta le cime boscose dei colli: è la Madre della vita e della morte; è la Moira. Come Luna, è signora del cielo; come Diana, è signora della terra: come Persefone, regina dell’oltretomba; come Musa, dà l’ispirazione ai poeti. Mentre nella religione olimpica la figura femminile viene inseguita, la Dea Bianca è l’Inseguitrice e la Violentatrice. Se il maschio è lepre, lei è levriero: se lui è pesce, lei è lontra: se lui è uccello, lei è falcone; se il maschio è chicco di grano, lei è la gallina, nera, che lo inghiotte. Non ci può dunque meravigliare se la Dea Bianca ci appaia come una strega che uccide i bambini, o che riempie i nostri sogni di incubi, o come l’ape regina dal pungiglione assassino. Via via che la sua figura diventa più oscura e terrificante, una estasi voluttuosa, un desiderio di dissoluzione precipitano Graves verso l’abbraccio mortale. Con sempre nuovi colori e sfumature e parole e variazioni, Graves tenta di disegnare il ritratto della Dea Bianca. Il ritratto ci sfugge, perché nessuno più di lei si sottrae alla presa. Finché Graves afferma: la Dea Bianca è l’Iside di Apuleio – questa divinità unica, che si manifesta in ogni forma e in ogni nome. Dapprima la incontriamo nella sua forma nera: come strega e negromante, che trae giù il cielo, innalza la terra, impietra le fonti, liquefa le montagne, comanda agli Dei, spegne le stelle e il sole, illumina il Tartaro, fa rivivere i morti. Infine, la Dea si rivela. In una notte di plenilunio primaverile, il disco rotondo della luna emerge dai flutti del mare, scintillando di un abbagliante candore: il mare è quieto, il cielo senza nubi; e questa magica congiunzione tra l’umidità marina, la rugiada generatrice e i raggi lunari, è l’epifania prediletta di Iside. Mentre Lucio dorme, la dea gli appare in sogno, con i foltissimi capelli ondulati, una corona di fiori sul capo, la veste di lino cangiante, la sopravveste nerissima splendescens atro nitore e luccicante qua e là di stelle. Sappiamo che è la genitrice di tutte le cose, la signora della natura, l’inizio della storia: la madre dolcissima e misericordiosa, che aiuta e salva gli infelici; quella Madonna pagana, quella Regina coeli, quella Stella maris, che Gérard de Nerval inseguì invano per tutta la vita. Notte di plenilunio – Non so se Iside sia veramente la Dea Bianca di Graves: dubito che la tenerezza materna, che attraeva tanto Nerval, affascinasse il suo spirito, che chiedeva agli dèi soltanto Venerazione e Terrore. È possibile che la Dea Bianca di Graves sia una dea molto più tarda: la Regina della Notte, che appare sulle scene del Flauto Magico di Mozart mentre i monti si spalancano sulla scena, o emerge all’ improvviso dall’abisso, tra il rombo furioso dei suoni. Certo, essa è ancora Iside: ha la stessa “nerissima sopravveste brillante di atro splendore” e luccicante di stelle; e conosce i dolori di Iside-Demetra, che percorre la terra coperta da un velo oscuro cercando le tracce della figlia scomparsa. Ma quando canta tra la tempesta dei suoni: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen,Tod und Verzweiflung flammet um mich her!…… Hort, Rachegotter! Hort der Mutter Schwur! La vendetta dell’inferno arde nel mio cuore,morte e disperazione fiammeggiano intorno a me!…… Udite, dei della Vendetta! Udite il giuramento della madre!: allora essa diventa un’oscura Erinni, che lacera ogni legame della natura. Forse la Dea Bianca, che Graves ha inseguito attraverso tante incarnazioni e trasformazioni, è, nel profondo, una Regina della Tenebra.
Notte di plenilunio – Non so se Iside sia veramente la Dea Bianca di Graves: dubito che la tenerezza materna, che attraeva tanto Nerval, affascinasse il suo spirito, che chiedeva agli dèi soltanto Venerazione e Terrore. È possibile che la Dea Bianca di Graves sia una dea molto più tarda: la Regina della Notte, che appare sulle scene del Flauto Magico di Mozart mentre i monti si spalancano sulla scena, o emerge all’ improvviso dall’abisso, tra il rombo furioso dei suoni. Certo, essa è ancora Iside: ha la stessa “nerissima sopravveste brillante di atro splendore” e luccicante di stelle; e conosce i dolori di Iside-Demetra, che percorre la terra coperta da un velo oscuro cercando le tracce della figlia scomparsa. Ma quando canta tra la tempesta dei suoni: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen,Tod und Verzweiflung flammet um mich her!…… Hort, Rachegotter! Hort der Mutter Schwur! La vendetta dell’inferno arde nel mio cuore,morte e disperazione fiammeggiano intorno a me!…… Udite, dei della Vendetta! Udite il giuramento della madre!: allora essa diventa un’oscura Erinni, che lacera ogni legame della natura. Forse la Dea Bianca, che Graves ha inseguito attraverso tante incarnazioni e trasformazioni, è, nel profondo, una Regina della Tenebra. Molti sono gli oracoli della Grecia e della Magna Grecia; ma il più antico è quello di Zeus a Dodona. Nei tempi passati due nere colombe si alzarono in volo da Tebe d’Egitto; l’una giunse ad Ammone in Libia, l’altra a Dodona; ambedue si posarono su una quercia che proclamarono essere un oracolo di Zeus. A Dodona, le sacerdotesse interpretano il tubare delle colombe o il frusciare delle foglie di quercia o il tintinnio dei vasi di bronzo appesi ai rami, Zeus ha un altro oracolo famoso in Olimpia, dove i sacerdoti rispondono alle domande, esaminando le viscere degli animali sacrificati.
Molti sono gli oracoli della Grecia e della Magna Grecia; ma il più antico è quello di Zeus a Dodona. Nei tempi passati due nere colombe si alzarono in volo da Tebe d’Egitto; l’una giunse ad Ammone in Libia, l’altra a Dodona; ambedue si posarono su una quercia che proclamarono essere un oracolo di Zeus. A Dodona, le sacerdotesse interpretano il tubare delle colombe o il frusciare delle foglie di quercia o il tintinnio dei vasi di bronzo appesi ai rami, Zeus ha un altro oracolo famoso in Olimpia, dove i sacerdoti rispondono alle domande, esaminando le viscere degli animali sacrificati. felce intrecciati; il terzo, con rami. di alloro; e che Efesto costruì il quarto in bronzo, con canori uccelli d’oro appollaiati sul tetto: ma un giorno la terra inghiottì questo tempio; il quinto santuario, costruito con pietra levigata, bruciò nell’anno della cinquantottesima Olimpiade (489 a.C.), e fu sostituito con il santuario che tuttora si ammira. Apollo possiede molte altre sacre sedi oracolari, come quelle sul monte Liceo e sull’Acropoli ad Argo, ambedue rette da una sacerdotessa. Ma a Ismenio in Beozia i suoi oracoli vengono emanati da sacerdoti che esaminano le viscere delle vittime; a Claro, presso Colofone, il veggente beve l’acqua di un pozzo segreto e pronuncia l’oracolo in versi; mentre a Telmesso e altrove si interpretano i sogni.
felce intrecciati; il terzo, con rami. di alloro; e che Efesto costruì il quarto in bronzo, con canori uccelli d’oro appollaiati sul tetto: ma un giorno la terra inghiottì questo tempio; il quinto santuario, costruito con pietra levigata, bruciò nell’anno della cinquantottesima Olimpiade (489 a.C.), e fu sostituito con il santuario che tuttora si ammira. Apollo possiede molte altre sacre sedi oracolari, come quelle sul monte Liceo e sull’Acropoli ad Argo, ambedue rette da una sacerdotessa. Ma a Ismenio in Beozia i suoi oracoli vengono emanati da sacerdoti che esaminano le viscere delle vittime; a Claro, presso Colofone, il veggente beve l’acqua di un pozzo segreto e pronuncia l’oracolo in versi; mentre a Telmesso e altrove si interpretano i sogni. Le sacerdotesse di Demetra danno oracoli per i malati a Patre, leggendo in uno specchio immerso in un pozzo con una corda. A Fare, in cambio di una moneta di rame, i malati che consultano Ermete sono certi di ricevere responsi dalle prime parole udite casualmente mentre attraversano la piazza del mercato. Era ha un venerabile oracolo presso Page; e la Madre Terra è ancora consultata a Egira in Acaia, che significa “il luogo dei neri pioppi”, dove le sue sacerdotesse bevono sangue di toro, veleno letale per tutti gli altri mortali. Oltre a questi, vi sono molti oracoli di eroi: l’oracolo di Eracle, a Bura in Acaia, dove si ottengono responsi lanciando quattro dadi e numerosi oracoli di Asclepio, dove i malati accorrono per conoscere la loro cura e ricevono il responso in sogno dopo un digiuno. Inoltre, Pasifae ha a Talame in Laconia un oracolo patrocinato dai re di Sparta, dove si danno i responsi sotto forma di sogni.
Le sacerdotesse di Demetra danno oracoli per i malati a Patre, leggendo in uno specchio immerso in un pozzo con una corda. A Fare, in cambio di una moneta di rame, i malati che consultano Ermete sono certi di ricevere responsi dalle prime parole udite casualmente mentre attraversano la piazza del mercato. Era ha un venerabile oracolo presso Page; e la Madre Terra è ancora consultata a Egira in Acaia, che significa “il luogo dei neri pioppi”, dove le sue sacerdotesse bevono sangue di toro, veleno letale per tutti gli altri mortali. Oltre a questi, vi sono molti oracoli di eroi: l’oracolo di Eracle, a Bura in Acaia, dove si ottengono responsi lanciando quattro dadi e numerosi oracoli di Asclepio, dove i malati accorrono per conoscere la loro cura e ricevono il responso in sogno dopo un digiuno. Inoltre, Pasifae ha a Talame in Laconia un oracolo patrocinato dai re di Sparta, dove si danno i responsi sotto forma di sogni. visto e udito. Calzati zoccoli da contadino, indossata una tunica di lino e una rete, come fosse una vittima sacrificale, egli si avvicina alla voragine dell’oracolo che somiglia a un enorme forno da pane, profonda sette metri, dove egli discende con l’aiuto di una scala. Giunto sul fondo, trova una stretta apertura in cui insinuerà le gambe, reggendo in ambe le mani un pane d’orzo impastato con miele. Dopo un improvviso strattone alle caviglie, gli parrà di essere travolto come dal gorgo di un fiume in piena e nell’oscurità sarà colpito alla nuca e gli parrà di morire, mentre una voce invisibile gli rivela il futuro e molte altre cose segrete. Non appena la voce si tace, il supplice perde i sensi e viene trasportato alla bocca della voragine con i piedi in avanti, privo delle focacce d’orzo; dopo di che lo si insedia sul Trono della Memoria, dove gli si chiede di ripetere ciò che ha udito. Infine, con la mente ancora annebbiata, ritorna alla casa del Buon Genio, dove ricupera i sensi e la capacità di sorridere. La voce invisibile è quella di uno dei Buoni Geni dell’età dell’oro di Crono, che discesero dalla luna e si incaricarono di presiedere agli oracoli e ai riti iniziatici, e di purificare, sorvegliare e salvare i mortali in ogni luogo; codesto Buon Genio consulta l’ombra di Trofonio, che ha la forma di serpente, e dà i suoi responsi in cambio delle focacce d’orzo del supplice.
visto e udito. Calzati zoccoli da contadino, indossata una tunica di lino e una rete, come fosse una vittima sacrificale, egli si avvicina alla voragine dell’oracolo che somiglia a un enorme forno da pane, profonda sette metri, dove egli discende con l’aiuto di una scala. Giunto sul fondo, trova una stretta apertura in cui insinuerà le gambe, reggendo in ambe le mani un pane d’orzo impastato con miele. Dopo un improvviso strattone alle caviglie, gli parrà di essere travolto come dal gorgo di un fiume in piena e nell’oscurità sarà colpito alla nuca e gli parrà di morire, mentre una voce invisibile gli rivela il futuro e molte altre cose segrete. Non appena la voce si tace, il supplice perde i sensi e viene trasportato alla bocca della voragine con i piedi in avanti, privo delle focacce d’orzo; dopo di che lo si insedia sul Trono della Memoria, dove gli si chiede di ripetere ciò che ha udito. Infine, con la mente ancora annebbiata, ritorna alla casa del Buon Genio, dove ricupera i sensi e la capacità di sorridere. La voce invisibile è quella di uno dei Buoni Geni dell’età dell’oro di Crono, che discesero dalla luna e si incaricarono di presiedere agli oracoli e ai riti iniziatici, e di purificare, sorvegliare e salvare i mortali in ogni luogo; codesto Buon Genio consulta l’ombra di Trofonio, che ha la forma di serpente, e dà i suoi responsi in cambio delle focacce d’orzo del supplice. Il racconto del mito di Antigone è collegato alla nostra recensione della collana “Grandi Miti Greci”, Volume 10:
Il racconto del mito di Antigone è collegato alla nostra recensione della collana “Grandi Miti Greci”, Volume 10: 